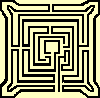|
Medusa
Il libro
Videoclip
Notizie sull’autore
Gianfranco Palmery
Dello stesso autore
Mitologie
Sonetti domiciliari
Gatti e prodigi
Giardino
di delizie e altre vanità
L’io non esiste
Il poeta in 100
pezzi
In quattro
Divagazioni sulla diversità
Italia, Italia
Profilo di gatta
Amarezze
|
Recensioni
del libro Medusa di
Gianfranco Palmery
L’ORO DELLA MUSICA
di Piera Mattei
Medusa, il nuovo libro di Gianfranco Palmery,
uscito nella collana «Tarsie» delle edizioni Il Labirinto,
è dedicato a Carlo Gesualdo e a Marin Marais, alla loro arte, che
un sostantivo e un aggettivo in originale accostamento definiscono musica
medica.
Due parole d’identico numero di sillabe, che iniziano con la stessa
consonante e sono quasi identiche. Se non fosse che, celate all’interno
del mosaico, una vocale e una consonante consecutive distinguono una parola
dall’altra. Ecco creata una vicinanza nuova, un’alleanza di
segni e suoni, che provoca la sensibilità e il pensiero. Le parole,
quasi fossero animate – e lo sono – hanno un destino che il
poeta ricerca e crea spostando le «tarsie» che lo compongono,
anche magicamente invertendo una vocale o un accento.
Musica medica, con rapida e inconsueta associazione parla di sonorità
e pause, accordi e dissonanze che curano la malattia del corpo e la sofferenza
del vivere. Musica ascoltata, certo, se la dedica è ai due grandi
musicisti barocchi. Ma anche musica composta, forse nell’ispirazione
di quella. Sollievo che provoca comporre – con tensione ossessiva
– la struttura delle parole e della frase.
«Doloroso / corroso», «malanni / affanni», «aspettando
/ bando»: assonanze soprattutto e rime, musica di consonanti doppie
in rapida successione, che ribattono su dolore e morte, sull’inverno
della vita. È difficile «fare fuoco», «è
solo fumo, fredda e nera cenere» (Soffiatenebre).
Ci troviamo all’interno di una poesia sotterranea, «infera».
Eppure proprio nel freddo più scuro, un’etimologia riscoperta
apre uno spiraglio a dotare una parola di una sua consistente infanzia
e di un’inattesa luce. In Au. C., l’oro come elemento
chimico, il suo fulgore come metallo «penetra dalla pelle / al cervello
[…] inaura il sangue, un’aurora / eterna [...]». Il rapporto
riscoperto, quasi per grazia, tra la medicina che il malato assume (che
contiene oro in proporzioni omeopatiche) e l’aurora che accende di
oro il cielo, conduce dal chiuso delle notturne stanze verso l’aperto.
Verso un cielo di pioggia e da Apocalisse, perché il poeta non
potrà rinnegare, proprio adesso, il suo senso del vivere. Irrompe
allora in una serie incalzante di interrogazioni profetiche, accusatorie
– nonché ironiche: «Cosa scende dal cielo? Fuoco? Infuriate
/ faville da spade fiammeggianti o ardenti / penne […]?» (Cosa
scende dal cielo). Le Furie sono uscite dal chiuso e l’universo
si è riempito di suoni dissonanti, pretese egoistiche, egocentriche
a miliardi: «flutti e flauti e l’infinito stridio / d’io
a miliardi […]» (Per flutti e flauti).
Eppure il poeta si trova costretto a una svolta, a una resa: «Giù
lungo a terra, scoperto, deposte / le armi, le armate grinfie, sotto /
gli occhi del padrone […]» (Gatto di Dio); «Ma
pace, adesso, mercé, miserere […]» (Miserere).
E ancora, ecco cosa c’è di nuovo nella notturna poesia di
Palmery: «Niente più notti illuminate […]» (La
notte e le sue noie). Da una fessura del buio è penetrato un
raggio celeste, un «azzurro alone, pallido / cerchio riparatore
[…]» (Per Enne). Azzurro è lo sguardo della donna
che dà luce allo sguardo e conduce verso il giorno, per amorosa
pietà e per sapienza e saggezza, come Beatrice e Lucia nella Commedia
dantesca. La vita rinasce «albale»: con l’oro dell’aurora,
il celeste chiarissimo dell’alba. È l’ora che confina
con la notte e l’allontana «Luce celeste […] fa cielo
col suo raggio» (Luce celeste).
C’è dunque il colore celeste ma anche il verde, il rosso,
in questa raccolta dal titolo color della pietra. C’è soprattutto
molto cielo, un cielo non assimilato al sole, casomai, come abbiamo visto,
al fuoco. Il sole certo illumina, ma in maniera persecutoria, incollando
ai talloni «un triste strascico» di tenebra (In sol).
Più frequentemente, qui, il cielo è associato all’acqua,
alle impietose alluvioni, alle burrasche: «c’imbeve di oscure
/ grazie – cancella luce e tempo, tenace / ammassa onde-nuvole, schiume:
un Tirreno / pronto a riversarsi in terra« (L’impluvio).
«Acqua a folate a raffiche da un cielo / affollato di nuvole stagnanti»
(Meteorologie); «la luce / cieca del cielo che mortifica
/ il fuoco delle rose […] discesa d’acque / grigie, petali:
niente» (Pentecoste d’acqua).
Ancora rovistando tra cimiteri di lasciti e senza rinnegare le «Muse
Meduse», questo libro esce a incontrare il cielo, la sua furia meteorologica,
le sue lingue di fuoco. Non abbandona la ferocia dell’enigma ma si
arrende a quanto, come la musica e i protettivi sguardi, sente disperatamente
consolatorio. E la stessa voce che detta la poesia, con i suoi ripetuti
«deliri d’odio / e scontento» – la tremenda musa
dal capo irto di serpi – è degna di uno sguardo d’umana
pietas, lei «bambina ottuagenaria», nella dialettica
di un’altra voce che si esprime con distacco apollineo.
«Pagine», XIII, 34, gennaio-aprile 2002
LA MEDUSA DI GIANFRANCO PALMERY
di Tiziano Salari
Medusa: sia che possa apparire sulle mura della città
di Dite, nell’inferno dantesco («Vegna Medusa: sì ’l
farem di smalto»), sia nel senso freudiano dell’orrore dell’evirazione,
è la vista di qualcosa, di un volto o di un vuoto o della morte,
che pietrifica l’osservatore. Nella prima delle tre poesie dedicate
esplicitamente alla Medusa, sembra che Palmery, pur rifacendosi all’iconografia
mitica tradizionale, una testa staccata dal corpo, sanguinante e raccolta
in sé come una furia spenta, coi capelli raffigurati in forma di
serpenti, la identifichi con la poesia, ovvero l’oscura scaturigine
infernale, «luce nera / sulla pagina bianca – e musica / sbilenca,
sibilante – musa-sibilla –:» in cui si forma la poesia.
In Medusa 2 e Medusa 3, viene ripresa la stessa ossessione,
la stessa identificazione della Poesia con la Medusa, fino a una totale
coincidenza, in cui i capelli-serpenti del mito diventano i «pensieri-serpenti»
che saettano i loro veleni sul foglio. Quindi la poesia, per Palmery,
non è salvifica, rasserenatrice, ma trasuda di pathos, è
scrittura del corpo, della passione, del dolore, del male. Risaliamo quindi
lungo il piccolo e ultimo capitolo del canzoniere del poeta romano, che
costituisce un ulteriore approfondimento del suo discorso poetico neo-barocco,
che ha, nell’attraversamento delle vanità del suo libro precedente,
Giardino di delizie – col suo riferimento, in nota, «quale
occasione, accidentale ma decisiva, per la nascita del libro», al
catalogo di una mostra, Les Vanitées dans la peinture au XVII
siècle (Caen, luglio-ottobre 1990) – quasi la fondazione
di una poetica e di uno statuto categoriale. Medusa (Il Labirinto,
Roma 2001) inizia con una nota dolente, da basso d’organo, come sussurrata
alle ombre, nel buio di una stanza:
Tutto un inverno nero, doloroso,
da passare così, all’oscuro, il cuore
assediato dai ricordi, corroso
il corpo da rodenti malanni:
gelo e tenebre e a orchestrare, il rimpianto:
sarà un inverno di fami, d’affanni
da passare così, solo aspettando
che passi: un tempo senza tempo – come
fosse già cominciato il freddo bando
dei morti, perduto il corpo e il nome.
Ed è questa la musica che ci accompagna lungo
tutte le pagine del libro, immergendoci in «gelo e tenebre»,
a compulsare i nostri mali e i nostri ricordi fino a ritrovarci nella
dimensione di «un tempo senza tempo» e guardando la vita dall’al
di là della morte. Non, heideggerianamente, attraverso una decisione
anticipatrice, che ci fa prendere coscienza della nostra finitudine e
mortalità e libertà di scelta per una vita autentica da
opporre alla chiacchiera e alla dispersione nel mondo, ma piuttosto nella
coazione di uno stato simile alla morte. Palmery sembra qui riprendere
la tematica di un grande poeta romano del Novecento, Giorgio Vigolo, quando,
in Circe, sente la sua vita condannata all’aridità
e al vuoto e si consegna inerme ad essere preda della disperazione: «Solitudine,
hai vinto!». La poesia determina una lontananza dall’io, «perduto
il corpo e il nome», ma non dall’essenza creaturale del poeta,
per il quale, come per l’uomo barocco, la creatura è lo specchio
nella cui cornice si svolgono le sconsolate stazioni della vita umana.
Ma diversamente che per l’uomo barocco, circondato da emblemi, blasoni,
ossa, teschi, a ricordare in permanenza la caducità delle cose
sensibili, a denudarle nella loro essenza mortale di fronte all’eternità
di Dio, per l’uomo moderno, come Palmery dice nei versi di Soffiatenebre:
[…]
Non c’è più un dio cruciato o zufolante
che mi protegga – né un agnello né un capro:
spoglio disperso spossessato:
[…]
Dio è morto e nessun raggio di luce dissolve le
tenebre. In È tutta qui la festa? l’assenza di trascendenza
rende senza senso le ferite che portiamo impresse a marchio di fuoco nella
nostra esistenza e che continuano a suppurare... «È l’esperienza
del male di vivere che interroga il problema del male alla radice»
(Giorgio Franck, La gioia, il dolore, l’eccesso, in «Trame»,
2, Il Male, a cura di Franco Rella, Pendragon, Bologna 2001).
Ed è una profonda esperienza del male di vivere quella che risuona
nella poesia di Palmery e lo spinge a interrogarsi sulle radici del male.
In Exit:
Un malato pensa il suo male – è il suo
pensiero, il suo peso, la passione
pratica del suo apparecchiare
la morte: non prega, non lavora
per la gloria del cielo o della poesia:
[…]
Ne L’assedio è la musica dissonante
dei rumori che ci perseguitano nella vita ordinaria e dalla quale il poeta
chiede invano di essere risparmiato. In Cosa scende dal cielo,
il cielo resta terribilmente muto e squallido per chi non si aspetta più
nulla dal cielo, né messaggi infernali né paradisiaci. «Quando
la sofferenza non è più un episodio – un tormento del
quale avvertiamo prossima la fine –, quando pensiamo di avere perso
ogni cosa e sentiamo che non c’è via d’uscita, quando
un dolore che sembra interminabile ci trascina nel gorgo della desolazione,
allora per noi tutto è male; e il male – essendo tutto ciò
che esiste – si rende uguale all’esistenza in ogni sua forma»
(Giorgio Franck, cit.). Tutto è male, dunque, come nel
giardino leopardiano (Zibaldone, 4174-4175-4176) che a poco a poco
si rivela «un vasto ospitale», nel quale il poeta si aggira,
come In sol:
[…] un corpo che fa ombra
e si muove col suo mutevole
angolo d’angoscia a novanta gradi:
[…]
Gianfranco Palmery ritrova nella sua poesia accenti che
sembravano scomparsi dalla poesia italiana dopo Sbarbaro o Vigolo, di
autentico dolore e intensità, in cui il soggetto poetico coincide,
inesorabilmente, con la propria ossessione. Il poeta attraversa la vita
come chiuso nel sepolcro del suo corpo. E la poesia? La poesia
è il sole nel sepolcro, con i suoi pallidi
raggi di pietra – luna diurna, lume
che anella notte a notte in un’eterna
notte senza sonno – o chiara, o eterna
notte di profondissimo sonno! e quel solo
suono che sale serpentino splendente
dalle oscure necropoli della mente.
E Medusa, la «luce nera / sulla pagina bianca»?
Nessuno ne ha trattato con la competenza di Paul Celan in Il Meridiano,
il discorso che tenne in occasione del conferimento del Premio Georg Büchner,
riprendendo una frase del Lenz dello stesso Büchner: «Si vorrebbe
essere un volto di Medusa»... «È come un porsi fuori
dell’umano, un trasferirsi, uscendo da se stessi, in un dominio che
converge sull’umano ed è arcano – il medesimo in cui
sembrano essere di casa la figura scimmiesca, gli automi e con questo…
ah, anche l’Arte». E questo richiamo di Palmery alla testa
di Medusa (che campeggia anche nei tre disegni dell’autore che accompagnano
il testo), in rapporto alla sua poesia, non è altro che l’attraversamento
di Das Unheimliche, del perturbante freudiano in cui l’orizzonte
della familiarità si converte in fonte di estraneità e di
orrore. «Forse – poiché l’estraneità, ovvero
l’abisso e il volto di Medusa, l’abisso e gli automi, tutto
sembra allinearsi nella stessa direzione, – forse le riesce di distinguere
tra estraneità ed estraneità, forse proprio qui il volto
di Medusa si atrofizza, forse fanno cilecca gli automi, proprio qui –
per questo incomparabile breve istante? Forse qui con l’io –
con questo io affrancatosi qui e in tale modo – forse qui si libera
ancora qualcos’altro?» (Paul Celan, Il Meridiano, in
La verità della poesia, a cura di G. Bevilacqua, Einaudi,
Torino 1993). Ed è questo anche lo stretto passaggio tra il dolore
e il male in cui si è incuneata la poesia di Palmery, alla ricerca
di una distinzione tra estraneità e estraneità, quando nel
congedo, nel rivolgersi alla musa e alla sua coazione a ripetere «deliri
d’odio e scontento», il poeta dice di ascoltarla
[…] mentre seguo
la voce paterna che mi parla
con apollinea complicità.
«Forse qui si libera anche qualcos’altro?».
Forse «il sole nel sepolcro» (pag.20), la «luce celeste
che risveglia / tutte le virtù del corpo» (pag.31), o «quella
luce / catacombale – vita renata – dove / la vita rinasce, azzurra,
/ albale» (pag.39) o «nella mente la luce / della vita perduta»
(pag.44) sono questo qualcos’altro, il rasserenamento apollineo (e
momentaneo) del male e del dolore? Forse.
«Testuale», XIX, 33, 2002
MEDUSA
di Annelisa Alleva
Questa raccolta è stata scritta nel 1996, e ispirata dall’ascolto
dei madrigali di Carlo Gesualdo e dalla lettura de La morte negli occhi
di Jean-Pierre Vernant. Di qui la Medusa. In questo volume, e nella precedente
raccolta Giardino di delizie e altre vanità, l’autore-untore
di se stesso si descrive con più abbandono, maggiore accettazione
di sé e dei propri demoni. Ammette di essere stato empio, di aver
fatto scempio della propria vita, ferreo restando il controllo dello stile:
«Sono stato un tiranno, un despota / con il corpo, un monarca spagnolo
o un principe / cinquecentesco – un Valentino: volontà e /
veleni». Malato di assolutistica intransigenza e indignazione, qualità
che sembra assumere su di sé per tutti quelli che non ne sono capaci,
Palmery si colloca in quella sottile intercapedine tra la vita e la non
vita. Dal suo tavolo di lavoro ha scaraventato a terra tutti i ninnoli
con quella che lui chiama «la mano che scanna», e si è
ritrovato solo di fronte al tempo che scorre e gorgoglia parole, alle
stagioni, con il cielo in alto, fuori della finestra, e gli inferi sotto
– morte, traffico, rumori che siano –, ai quali, tutti, offre
la resistenza dell’asceta convinto ma stanco, tormentato, battuto,
oppresso, ossessionato. Meteorologo meteoropatico, antifamilistco e antiretorico,
benedicente solo gli amati maledetti Poe, Baudelaire, il Baron Corvo,
Palmery sembra accettare la luce solo quando è mediata dagli occhi
della sua donna: «Se / tu non spandessi un azzurro alone, pallido
/ cerchio riparatore, chi vorrebbe – non è / petrarchismo
tombale – tirarsi su, aprire / gli occhi, accogliere il rumore dei
giorni?». Il barocchismo borbottante di Palmery, le paturnie stilate
con gusto tagliuzzante, arrivano a elencare alla fine di una poesia, come
residuo sul fondo di un tino: «Orine yogurt Dio». Scandirei
le tre parole a motto, emblema ultimo del ribellismo disperato di questa
poesia.
«L’Indice», 4, aprile 2002
|