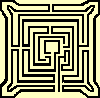| Sonetti
domiciliari
Il libro
Videoclip
Notizie sull’autore
Gianfranco Palmery
Dello stesso autore
Mitologie
Gatti e prodigi
Giardino di delizie e altre vanità
Medusa
L’io non esiste
Il poeta in 100 pezzi
In quattro
Divagazioni sulla diversità
Italia, Italia
Profilo di gatta
Amarezze
|
Recensioni
del libro Sonetti domiciliari
di Gianfranco Palmery
SONETTI DOMICILIARI. ANTEPRIMA
di Vincenzo Anania
Da qualche tempo in Italia si fa un gran parlare di misure
cautelari limitative della libertà personale, nella forma della
custodia in carcere e in quella, ovviamente più attenuata, degli
arresti domiciliari, per effetto dei quali l’imputato è costretto
a starsene in casa senza poter uscire e, se esigenze processuali lo richiedono,
nemmeno comunicare con l’esterno.
Gianfranco Palmery, per sua e nostra fortuna, è incappato nella
meno grave delle due ipotesi. Ce lo annuncia e racconta in Sonetti
domiciliari, quinto dei suoi libri di poesia, edito da Il Labirinto,
e qui presentato in anteprima con alcuni dei quarantadue sonetti e con
due dei disegni di Nancy Watkins che adornano il volume.
Il libro è molto bello, tra i migliori dell’opera complessiva
dell’autore, che con rocciosa coerenza tematica e stilistica, in
un progressivo arricchimento e affinamento dei mezzi espressivi, vi ha
rappresentato la propria ostinata lotta in versi contro il Nulla e la
sua ancella Morte e contro i Demoni dei propri desideri vizi e ambizioni;
una battaglia che fin troppo lucidamente il poeta sa persa dall’inizio,
ma che finisce con l’apparire l’unica opera per cui valga la
pena di vivere (L’opera della vita è il titolo del
secondo libro di Palmery – Edizioni della Cometa, Roma 1986). Scoprire,
stanare, rivelare, nelle sue mutevoli figurazioni il Nemico annidato nelle
più recondite pieghe dell’esistenza, seguirne passo passo
l’opera di distruzione, e il sordo lavorio nel proprio corpo, nella
stessa parola poetica; questo l’impegno, direi la missione, che Palmery
ha assunto con se stesso. Insomma: il coraggioso «scandalo dei contenuti»,
«l’impudica disperazione», ben messi in rilievo da Luigi
Baldacci nella prefazione a Il Versipelle (Edizioni della Cometa,
Roma 1992); disperazione e scandalo del tutto anomali rispetto al dogma
dell’anti-romanticismo, alla rigida regola della «decenza»,
da tempo vigenti nella poesia moderna.
Da tale coraggio dell’indecenza così come dall’autenticità
di tanta disperazione fui anche io affascinato quando m’imbattei
in questa poesia. Ma soprattutto mi avvinse l’elevatissima qualità
della scrittura. Perché le ossessioni di Palmery, le ambientazioni
funeree, le implacabili crudeli registrazioni «profetiche»
della dissoluzione della propria carne, dell’annichilimento del tempo
e dell’umano operare, vengono imbrigliate e ingabbiate, talvolta
sia pur per poco addomesticate, in un involucro formale ricchissimo, scintillante,
vitale, che pur dispiegandosi in tutti i fasti possibili della tecnica
poetica, è sempre funzionale al tema e, quel che più conta,
alla resa poetica del testo. Peraltro, se nella scrittura di Palmery,
nel lessico come nei moduli sintattici e metrici, nulla è moderno
– se con ciò si intende aggiornamento, avanguardia –
profondamente moderno è invece il suo stile, in quanto corrisponde
all’esigenza sempre più pressante, da qualche tempo riscoperta
da autorevoli critici, di riavvicinare la poesia al lettore. In esso infatti
ravviso un esemplare di quel «Grande Stile», propugnato da
Gian Luigi Beccaria (in «Sigma», XVI, 1983 – p. 8): una
forma alta, nella quale però «il pullulare dei particolari»
sia organizzato a vantaggio di una essenzialità, venga inserito
in una continuità che tenga conto della tradizione e si curi della
comunicazione.
Ne deriva un profondo coinvolgimento del lettore, una sua costante «accensione»
poetica, così che dal testo egli riceve robuste dosi di energia.
È il paradosso principe, intensamente dialettico, di questa poesia:
l’insistita contemplazione e denuncia del Nulla, la gridata consapevolezza
della vanità e del corrompersi del tutto, che alla lunga potrebbero
risultare deprimenti, lasciano nel lettore una sensazione di forza, di
accresciuta energia, proprio grazie al suddetto fastoso scialo formale.
Chi legge è portato d’un fiato dal primo all’ultimo verso,
non solo dalla complessità e fluidità del pensiero poetante,
dalla pregnanza e dallo splendore delle immagini, ma anche in virtù
dell’incalzare di rime interne e esterne, del turbine di assonanze
e di allitterazioni, del sapiente alternato dosaggio di violenza espressiva
e riposanti pause, con conseguenti briosi contrappunti fra i ritmi celati
e quelli in evidenza; e non va dimenticata la rara capacità di
cogliere complesse serie di correlati analogici alle immagini centrali;
e metrica incalzante, percussiva, vitalissima appunto. Un esempio: nella
poesia Allora (Il versipelle, op. cit) – che si conclude
con la drammatica enunciazione che già nella giovinezza del poeta
«… in segreto si aggirava facendo / i suoi calcoli la Distruzione»
– i versi iniziali sono: «è stato allora quando il mio
corpo / era un palazzo spalancato e lampade / e fiaccole, un fuoco vivo,
lo illuminavano / a giorno e una notte interminabile ardeva / invaso edificio
in fiamme / o in perenne festa, un festoso inferno / dove sfrenarsi passando
da un girone / all’altro…».
E comunque, laddove più fitte si fanno le tenebre in cui il poeta
sovente ama avvolgersi, si accendono i falò di un’agile e
elegante ironia, auto-ironia soprattutto, che stempera e smussa e ancora
una volta vivifica, immettendo questo dramma esistenziale, che tutti ci
riguarda, in quell’agone ludico di confronto e scontro fra sofferenza
e allegrezza, dove si realizza la migliore poesia. Insomma Palmery sa
anche ridere, divertirsi e divertirci. Seguiamolo nella lamentazione sulla
sconfitta delle sue ambizioni in Domenica delle Palme (Il versipelle,
op. cit.): «Giorni che avrei voluto palmari, in palma / di mano,
dalla gloria portati, trionfali, / da sempre invece palmeriani, amari,
mai / da aurei rami di palma salutati / come si benedice un fulmineo,
mite / passaggio sulla terra – ma estenuati / dall’attesa in
un tempo eternamente / esitante e senza esito…».
Ma è tempo di tornare al nuovo libro di Palmery, questo Sonetti
domiciliari che a mio avviso ha un pregio in più rispetto al
lavoro precedente. Mi riferisco alla tonalità complessiva, e in
particolare all’elemento musicale. C’è una maggiore levità,
meno acre l’ironia, piu sobri le architetture e i fondali, colori
fondamentali e pastosi, e una sorta di appeasement: se non proprio
resa al Nemico, più serena accettazione della sconfitta inevitabile.
Si ha anche l’impressione che la consueta metrica incalzante qui
spesso si melodizzi in cadenze di danza, a volte in puri «cantabili».
Insomma lo spartito sul quale Palmery suole sapientemente lavorare, acquista
in questi sonetti una sonorità più prettamente italiana,
fra il «bel canto» e i crescendo rossiniani, l’emotiva
liricità dei «larghi» verdiani; così facendo
risuonare al meglio la nostra bella lingua. Non che mancassero esempi
nei libri precedenti; penso alle poesie per gli adorati gatti, fra le
migliori che abbia mai letto sui proverbiali amici dei poeti, resi da
Palmery carnali e metafisici nello stesso tempo; penso anche allo straordinario
testo sul suo fare poesia, ancora ne Il versipelle: «Le poesie
adesso le faccio a terra / – trascinando i piedi o dietro i piedi
/ andando strenuamente, costretto a continue / soste, soffermandomi a
meditare / sui passi già fatti, infinite volte / tornando indietro,
provando e riprovando / a marciare – poiché così vuole
il tempo, / lo spazio è questo, stretto, e questo / è il
movimento che posso fare e che non posso / non fare, il verso che ora
devo seguire…».
In questi nuovi sonetti, però, la solare sonorità della
lingua italiana è costante, sostiene la quieta luce della casa,
dà luminosità a tutti i suoi oggetti. Penso al sonetto 24:
«Tra una poesia e l’altra si distende / la prosa dei giorni…»,
dove ciò che resta «fuori dalla poesia» è latte,
pane tagliato, barattolo del miele, il tutto soffuso di luce morandiana,
forse anche per il suo essere fuori e insieme accanto alla poesia. E cito
anche l’arioso volatile attacco del sonetto 9, rivolto ai (suoi)
pensieri: «Non fermatevi, non fatevi afferrare / da questa mano
armata che vi tallona / vi punta: volate lasciatevi dimenticare / come
i sogni o i piu fuggevoli gesti / del corpo scritti nell’aria…».
E allora, futuro lettore, accompagniamo questo poeta nella struggente
e mitica orchestrazione della sua casalinga quotidianità, nella
casa in cui si annullano le forme del tempo («Il passato, il presente:
solo quinte», son. 15). Seguiamolo nel suo gemente e ilare, e bilioso
e disarmato e malizioso e innocente, vagare negli insoliti arresti domiciliari;
guardiamolo con occhio possibilmente benevolo mentre, sia pure ridacchiando,
e proclamando il «vanitas vanitatum», si consuma fra
ambizione e scoramenti, o si trascina saltella ciondola di stanza in stanza,
rubacchia in cucina, si accapiglia con i dèmoni rimettendoci capelli,
si abbassa in umile devozione a raccogliere le feci dei gatti, mentre
i dèmoni, stolidi e implacabili carcerieri, tagliano i fili del
telefono, intercettano la posta. Finché scopriamo che quei dèmoni
«non sono che queste anime morte / che ti circondano – o Italia
deturpata dalle imposte / e dagli impostori!…»; e da (altro
tipo di) imposte il poeta la spia «… mentre fa / festa sciamando
alla sua amata rovina» (son. 13). E poi, altro colpo di scena in
questa vicenda che non manca di suspense, scopriamo che è
lui, il poeta, a chiuder fuori «l’inferno, tenendo tutte le
finestre / chiuse» (son. 16) e che, gran sorpresa finale, lui stesso
si è messo agli arresti domiciliari, per evitare la prigione là
fuori e quella interiore ad ogni uomo; egli che ha in sé «…
lo stigma del prigioniero / che a tutto imprime la sua prigionia»
(son. 9).
Nel quarantaduesimo ultimo sonetto, il poeta si congeda con un «avviso
al lettore»: «Lettore, tutto quello di cui ho scritto / non
c’era più già mentre lo scrivevo: / trapassato, sparito,
come il pensiero / che ne portava il riflesso…» e che «confitto»
nel testo poetico diviene «una spoglia che ancora dice "esisto"
–». Ma in verità è solo una «forma del
niente» che seguita a dire a chi legge: «io esisto, sono l’inesistente,
/ che è stato, come ora il tuo, un presente».
Ebbene, questo conclusivo atto di contrizione non mi convince, è
finale che volge al nero la storia narrata nel libro, così ricca
invece di humour e di situazioni e personaggi – compresi i dèmoni
e altri fantasmi – molto vitali, nonché di oggetti fiutabili
visibili degustabili ascoltabili, totalmente offerti ai sensi del lettore;
e tutti proclamano il loro esistere, il piacere che ne viene. Ma soprattutto,
all’altro corno del paradosso entro il quale il poeta si dibatte,
è una verità sostanziale, concreta che si manifesta e svolge
sotto gli occhi del lettore, la verità che costantemente contraddice
il dominio dell’inesistente del vano e del fatuo cantato da Palmery;
intendo la verità del suo scrivere, del suo far poesia e la strenua
sconfinata passione che l’alimenta, così radicando al vivere
il poeta. Una passione dello spirito, ma che non nasconde le sua fondamenta
carnali. Si legga l’esemplare sonetto n. 4 – vera chiave del
libro, e forse al di là della consapevolezza dell’autore,
anche del suo pensiero poetante – nel quale si realizza l’identificazione
della poesia con il corpo e il tempo del poeta: «Da giorno a giorno
una rete di versi / come vene e nervi si dirami li attraversi / e in un’unica
trama li anelli li intrecci / fatta di me, delle mie vene e nervi / …
– perché il tempo di giorni non persi / si tenda e corra in
essi – oh versi / garretti del tempo, sue vene! …».
E quanto ancora aspira Palmery – anche se la dichiara già
dissolta, un «… faticoso fantasma / dipinto sul soffitto della
cella» (son. 21) – a «quella poesia raggiante, stellare
/ che balenava in sogno…» (son. 20)! Dunque paghi pure il poeta
i suoi tributi al Nulla, proclami ancora la vanità del tutto, ma
continui, per sé e per i suoi lettori, ad alimentare l’ambiziosa
concretissima passione dello scrivere, e senza discolparsene troppo; tanto
più che come Leopardi ammonisce (Zibaldone – 225, 23/8/1820)
ogni scrittura non sorretta da passione è (quella sì) vanità.
«Pagine», V, 10-11, gennaio-agosto 1994
«RINCHIUSO
IN CASA, SUL FUOCO LA CUCCUMA»
di Domenico Adriano
«Poesia, mia paziente giardiniera, / taglia sfoltisci metti ordine
/ nel groviglio dei pensieri...». E altrove: «Mi sono perso,
non ho / più notizie di me – o piuttosto ho / notizie minime,
di tutti i giorni». Con una poesia «fatta in terra, in casa»
ci viene incontro Gianfranco Palmery, nella sua ultima opera, quarantadue
Sonetti domiciliari, usciti dalle mani di un faber che ha
la maestria di lavorare dimenticando ogni volta la sua perizia... Ma non
ci si lasci ingannare dai tempi, dai fatti e dai luoghi. Il pensiero qui
vola alto, e la materia è quella trasparente, del «pensiero
inafferrabile e vivo, evanescente- / mente estraneo alla sua vanità».
Non il corpo, o le ceneri, del poeta santificano le quattro mura dell’esilio
terreno. ma il pensiero, il fuoco del pensiero che brucia di sé
e se stesso per farsi «planetario», parola udibile, verbo,
pur nella coscienza della propria solitudine in cielo come in terra; pur
nella certezza della sola possibilità di vita nel viaggio tra il
cielo e la terra.
«Avvenimenti», VII, 41, 26 ottobre 1994
SONETTI
DOMICILIARI
di Cinzia Monti
I poeti sono misteriosi, e spesso lo sono anche a se
stessi. Forse questo potrebbe bastare a chi volesse indagare le ragioni
di una scelta esistenziale tutta risolta nel consapevole e volontario
isolamento, nel rifiuto del mondo che questi Sonetti domiciliari
di Palmery ci consegnano. Segregato nella sua casa-carcere di massima
sicurezza, penitenziario dotato di ogni comfort, egli sconta la pena di
vivere registrando in versi «domestici, domiciliari» «tormenti
oscuri, modesti», lui che non si sente «né eroe né
saggio né eremita / o eretico cruciato» e che, guardandosi
nello specchio, si vede come «fatuo accidente del caso». E
tuttavia questo spazio carcere, questo universo claustrofobico, sentito
ora come condanna ora come privilegio, rimane l’unico possibile per
lui che con «gesti pazienti e ostinati» compie «il suo
ostinato mestiere». È un mestiere che costa «fatica
e pena», ma che pure lo sottrae «all’orrore / medio che
mette la vita alle strette». È azzardato allora concludere
che anche per Palmery, come per altri prima di lui, rinunzia al mondo
equivale a dominio sul mondo?
I Limoni – La poesia in Italia nel 1994
a cura di Francesco De Nicola e Giuliano Manacorda
Caramanica, Marina di Minturno 1995
|