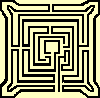| Mitologie
Il
libro
Videoclip
Notizie sull’autore
Gianfranco Palmery
Dello stesso autore
Sonetti domiciliari
Gatti e prodigi
Giardino di delizie
e altre vanità
Medusa
L’io non esiste
Il poeta in 100
pezzi
In quattro
Divagazioni sulla diversità
Italia, Italia
Profilo di gatta
Amarezze
|
Recensioni
del libro Mitologie di
Gianfranco Palmery
GIANFRANCO PALMERY. MITOLOGIE
di Lucio Felici
In altri spazi si muove la poesia di Gianfranco Palmery,
anche lui romano, ma della nuova generazione. Nella sua breve raccolta
(Mitologie, Edizioni Il Labirinto, Roma 1981) non si scorgono tracce
di appartenenza a gruppi o scuole, né riferimenti espliciti a concetti
storico-sociali: semmai, nell’uso distillatissimo del verso, rastremato
fino a una linea musicale stridula e sottile, addensato sull’immagine
più contratta e vibratile, si può indovinare, di lontano,
la lezione dei grandi decadenti e simbolisti francesi. Quella di Palmery
è una lirica raffinata e crudele, che si accanisce sull’anima
e sul corpo per demolire ogni trucco o mitologia, in un angoscioso e impietoso
agonismo dell’«io» con se stesso, in un incessante spiare
di moti furtivi, scatti felini (l’immagine ricorrente del gatto)
tragicamente – e ironicamente – proiettati in cortei di fantasmi
e tenebre:
Verità della vita, menzogna
e morte, vi riconosco, da sempre
mie innamorate scorte... (p. 19).
Non la morte, non la poesia, soltanto
le tenebre: le chiamo e subito
accorrono, si accalcano – io le ricevo da re,
da re morente, abbandonato sul letto...
Per tutto il giorno sfilano discrete
o si affollano al mio capezzale come
intorno a un trono (p. 21).
Dove l’ultima salvezza (o illusione di salvezza),
nel deserto della rinucia e della «inazione» (il «letto»
è l’emblema di una scelta valetudinaria) è la resa
con «regalità».
«Studi Romani», XXX, 3, Luglio-Settembre
1982
SU PALMERY E MITOLOGIE
di Raffaele Pellecchia
La poesia di Gianfranco Palmery appare tutta risolta
all’interno di una compitazione «lirica raffinata e crudele,
che si accanisce sull’anima e sul corpo per demolire ogni trucco
o “mitologia”, in un angoscioso e impietoso agonismo dell’io
con se stesso, in un incessante spiare di moti furtivi, scatti felini
[…] tragicamente – e ironicamente – proiettati in cortei
di fantasmi e tenebre» (L. Felici). La poesia di Palmery è
una poesia postuma: è la registrazione di una sconfitta esistenziale
e dei rari e già saputi fallimentari tentativi di fuga, ovvero
l’ipostasi dell’ineludibilità della resa: i suoi emblemi
sono Amleto, il catoblepa che divora se stesso, Don Giovanni all’inferno,
il Minotauro prigioniero nel labirinto. La condanna consiste in una irreversibile
coazione a ripetere «l’ininterrotto melodramma» in una
esistenza «senza destino e senza destinazione», osservata
e giudicata con saggezza retrospettiva; e, perciò, senza scatti
e senza illusioni, senza «neppure più la furia il rancore»,
sul piano inclinato di una stupida ebetudine. Dal versante di una coscienza
adulta e disillusa, che la sa «lunga sul trucco e sul trucco dei
Trucchi / e su tutti i trucchi», Palmery gioca il suo ruolo di giocatore
perdente, apparecchiandosi a riscattare ogni residua dignità nell’accettazione
della perdita: «Non la morte, non la poesia, soltanto / le tenebre:
le chiamo e subito / accorrono, si accalcano, – io le ricevo da re,
da re morente, abbandonato sul letto […]»: così avviene
il riscatto, e la catarsi: attraverso un rito in cui il poeta diventa
sacerdote di se stesso e mediante il quale riacquista la sua regalità
e persino la sua divinità (o demonicità che è lo
stesso). Ma la calma «è solo / un’altra forma di pena»:
ovunque consiste «l’acerbo / ossimoro d’essere vivi /
e mortali», e ogni finto fulgore vitale porta i segni della sua
prossima morte, tornando «a un minerale / ordine elementare».
Si tratta, come si può cogliere dai brevi lacerti riportati, di
una poesia che rinvia con il suo sigillo aristocratico e prezioso, con
la sostenutezza del suo tono e l’elezione del suo lessico, a certe
vaghe ascendenze decadenti (Verlaine più che Mallarmé o
Rimbaud), da rintracciarsi sia nell’area latina che in quella anglosassone,
con in più una costante tensione al gesto e all’intonazione
drammatica, in una sorta di recita senza pubblico e senza teatro, con
spettatori assenti eppure supposti che consentono al linguaggio di caricarsi
emotivamente, risparmiando al poeta-attore l’impudicizia dell’esibizione.
La poesia nel Lazio, Forum / Quinta Generazione,
Forlì 1988
|