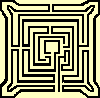| Lettere
tombali
Il libro
Notizie sull’autore
Jude Stéfan
Dello stesso autore
Alma Diana
|
Recensioni
del libro Lettere tombali di
Jude Stéfan
FINGERE PER DIRE IL VERO
di Sauro Albisani
Esce per le romane Edizioni II Labirinto, un secondo
libro, dopo Alma Diana, del francese Jude Stéfan, autore
a suo tempo proposto all’attenzione del lettore italiano da Sergio
Solmi e subito frettolosamente rimosso. C’è voluto ancora
il fiuto di un poeta, capace di confermarsi tale anche quando traduce,
c’è voluta la voce di Gianfranco Palmery per poter riascoltare
anche nella nostra lingua la voce di Stéfan.
Se tali vogliamo considerarle, le Lettere tombali sono lettere
che smascherano provocatoriamente il paradosso della corrispondenza, semplicemente
questo: che non può esserci corrispondenza, nel senso che non ci
corrispondiamo, che il carteggio corre sempre fra mittenti mentitori e
destinatari contumaci. Come leggere allora queste pagine? Lettere che
non arriveranno; lettere che è bene che non arrivino; lettere su
cui è stata messa, una volta per sempre, una pietra sopra. Una
pietra tombale. Un gioco, serio e ironico, di disguidi e di smarrimenti;
posta inevasa piena di pensieri evasi dalla cattività della noia
quotidiana, puntuale e metodica. Il bouquet che accomuna i titoli del
libro e che essi, una volta sorseggiati, lasciano nella mente è
ben presente alla coscienza di Jude, egli stesso l’addita come la
poetica dell’opera con parole che meglio non potrebbero esprimerla:
«[...] la retorica rispettosa dell’arte epistolare, che consiste
nel fingere per dire il vero» (A Sollers). Fingere per
dire, in realtà, il vero. Dunque, parafrasando: fingere di fingere.
Bene: così si scrive, o si scriverebbe, solo a qualcuno che non
può leggere, o almeno che non può rispondere.
Stante la cosa, cade clamorosamente quella censura che ci impedisce di
mettere a nudo latitudini interiori inaccettabili non solo agli altri
(cui tentiamo pur sempre di svendere, più o meno a buon mercato,
una personale agiografia edulcorata) ma anche a noi stessi. Questo mi
pare un punto importante. Le lettere di Stéfan sono scritte a posteriori
d’una particolare forma di suicidio realmente perpetrata: la soppressione
totale dell’amor di sé. Ciò che le rende vietate a
minori e maiores è il fatto che esse hanno un tono davvero postumo,
scritte in quella condizione di inerme, indecente e impietosa nudità
che solo la morte è capace d’imporre sulle nostre autodifese,
sulle nostre ipocrisie, sul teatrino dell’ego.
Il vuoto lasciato dalla soppressione dell’amore di sé introduce
il grande tema del disamore. Vivere è ammalarsi. Di che? D’essere
quello che siamo: «no, non mi sarò amato» (Alle
sorelle), «[...] se soltanto scrivere mi guarisse da me stesso»
(Ai poeti), insiste Jude senza andare troppo per il sottile fino
a parlare dell’ «abuso» della propria nascita: «[...]
io ho scritto per violare l’informe dei cieli e delle stagioni che
ci imprigionano, per rispondere all’abuso della mia nascita, per
dire no, no e no.» (Al lettore).
Mestiere giubilato, il postino è inutile nella terra di Stéfan.
Le lettere non sono mai state spedite. La speranza in Stéfan non
solo non produce il suo frutto (la delusione) ma neppure il fiore (l’illusione).
Da questo parlare après soi nascono argomenti e capitoli,
a cominciare da quello che investe causticamente la scrittura medesima:
ossia la dolente contezza dello scacco sofferto dalla petizione a durare
rivolta alle parole della poesia, il presentimento che queste non siano
se non cenotafi, morte crisalidi, «vesti adagiate a sbuffo sull’erba»,
e vuote dentro. Il nichilismo (troppo cogente per essere pronunciabile,
«come se la nascita ci lasciasse una scelta», A un editore)
si nasconde in agguato nel sospetto di «insulsaggine delle parole»
(Al suo cane), sospetto che sembra negare alla scrittura, nell’atto
di praticarla, il riconoscimento d’una qualsivoglia virtus euristica,
fino alla sua definitiva (e in fondo assolutoria) negazione («Ho
avuto bisogno di scrivere per rinunciare alla scrittura», Al
lettore). E sempre al disamore si collega l’ultranegativa teologia
stéfaniana, col suo Cristo della derelizione, apostolo o messia
del Nulla, cui il poeta è tuttavia disposto ad accreditare un’infera
disperata sacralità. Come non vedere nell’immagine (e nell’omonimia)
del Giuda evangelico che ripudia con orrore il Maestro per il suo «continuare
a pendere a tutti gli incroci al di là dell’oblio»
(Al Cristo) un autoritratto?
Persino l’amor carnale è piuttosto figlio del disamore, per
l’inevitabile contrappasso dell’erotismo e del piacere in
dolore e coscienza dell’inanità che porta l’uomo a
vivere l’amplesso non come ricerca del deliquio ma come battaglia
contro l’annullamento: una battaglia vana, perduta prima di perderla.
Penso a Stéfan e mi torna in mente Filottete: la bruciante certezza
di non identificarsi con la propria incarnazione è la sua inguaribile
ferita. Gli resta la nobiltà della noia, pronipote della noia leopardiana;
l’impossibilità di far domande, o meglio l’inutilità
(«è troppo presto troppo tardi»); la devastante consapevolezza
che l’unica cosa che dura è il non durare: immanente eternità
del dissolvi animadvertere («io non sono mai stato al passo
con la mia morte, che non ha fatto che correre davanti a me», A
Sollers).
Tuttavia, la conclusione non deve ingannare. Più che un devoto
della morte (alla quale oppone lo stoicismo di chi resiste alle sirene
d’un possibile/improbabile limbo), Stéfan è un apostata
della vita, il che non significa tout court un aspirante suicida.
Direi invece un moralista, cui non resta che attingere l’unico,
l’ultimo senso possibile delle proprie massime nella constatazione
che «l’universo non ha senso» (Ai poeti).
Rileggo le sue pagine e mi accorgo che Stéfan è uno di quei
pensatori (non sono tantissimi) che non menano il can per l’aia,
ma ti dicono come stanno le cose: puoi non credergli, però non
puoi non ascoltarlo. E non è poco.
«Pagine», XVI, 47, maggio-luglio 2006
LETTERE TOMBALI
di Marco Vitale
Eros e morte sono i temi che hanno caratterizzato fin
dall’esordio negli anni Sessanta la produzione di questo importante
poeta francese, nato a Pont-Audemer nel 1930, da noi ammirato e introdotto
da Sergio Solmi che ne curò per primo una raccolta (Guanda, 1979).
Una doppia tonalità che si evince fin dalla scelta dello pseudonimo,
posto sotto il duplice viatico di Thomas Hardy, quanto al prenome Jude
(l’oscuro), e di Joyce; ma, è lo stesso autore a svelarcelo,
«nell’antico inglese steorfan vuol dire morire /
e se levo via l’or / resta la mia vita incolore».
La poesia di Stéfan si pone dunque esplicitamente come esperienza
di confine, sonda dell’invisibile, interrogazione non consolatoria
sull’inespresso, e in questo getta a ritroso, sulle illusioni dell’aldiqua,
lampi di corrusca luminescenza. Il tempo, il nulla, il corpo che fa (talora
splendida) resistenza ma è teatro eletto del dramma, quale una
cittadella già in mano al nemico, sono temi che ritornano con cadenza
quasi ossessiva, e richiedono una scrittura dolorosamente essenziale,
capace di incidere senza compiacimenti sperimentalistici o colloquiali:
graver è per Stéfan sinonimo stesso di scrivere,
quanto non toglie alla scrittura potenza di accensione e torsione.
Ne abbiamo esempi significativi anche nei poèmes en prose
che compongono queste Lettere tombali, ottimamente curate da
Gianfranco Palmery che di Stéfan è in Italia il principale
traduttore e studioso. Indirizzate ad affetti immaginari – l’io
si libera dai lacci biografici al tempo stesso che stabilisce la realtà
della propria geografia emotiva – a poeti come Rimbaud o a scrittori
come Sollers, al proprio cane, a un editore, al Cristo, esse approfondiscono,
in virtù della loro «scrittura chirurgica» (Palmery),
una meditazione sulla vita di stoica severità. Ma questo non va
confuso, tiene a precisare Stéfan, col «termine quasi religioso
di “nichilismo”, parola che adoperano i pavidi, gli inconsapevoli,
i benportanti per riflesso impaurito: come se la nascita ci lasciasse
una scelta, come se la letteratura fosse un piacere e lo scrittore un
uomo come tutti».
«L’Indice», XXIII, 6, luglio-agosto
2006
|