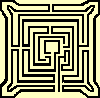|
I cavalli del nemico
Il libro
Notizie sull’autore
Alessandro Ricci
|
Recensioni
del libro I cavalli
del nemico di Alessandro Ricci
PER I CAVALLI DEL NEMICO
di Francesco Dalessandro
Alessandro Ricci, uno degli sventurati d’ogni tempo
che fanno della poesia la ragione della propria vita, nacque a Garessio
(CN) il 14 agosto del 1943, da padre romano; laurea in lettere, tesi lodata
su Fenoglio; appassionato di meccanica, di motori e d’ingranaggi,
per vivere avrebbe potuto fare il progettista d’automobili, ma scelse
di fare l’insegnante; partecipò alla realizzazione del film
di Vittorio De Seta Diario di un maestro; scrisse soggetti e
sceneggiature per cinema e televisione (alcune raccolte in volume nel
1980 col titolo La storia a misura d’uomo); ultimo film
scritto (con Claudio Bondì): De Reditu – Il ritorno,
dall’omonimo poemetto di Rutilio Namaziano; consumato in pochi mesi
da un tumore ai polmoni, quasi inevitabile per un fumatore accanito e
fino all’ultimo non pentito, è morto a Roma il 27 marzo del
2004. Prima e soprattutto, però, Alessandro Ricci è stato
un grande poeta, anche a dispetto di se stesso: i tre libri pubblicati
devono molto alle insistenze di amici. Eppure, nonostante i suoi pudori,
egli era consapevole del proprio valore e – contraddittoriamente
– soffriva per il suo mancato riconoscimento, poco però facendo
per rimediarvi: non cercò mai, per esempio, di pubblicare con i
grandi editori, quelli per intenderci che riescono ad imporre un libro
anche a dispetto del suo valore. Ci sono poeti – e Ricci era uno
di essi – che vivono ai margini del «gran spettacolo»,
non illuminati dalle luci di scena, per inguaribile modestia e mancanza
di vanità accontentandosi – e in ciò forse sbagliando
– d’essere letti solo da quei pochi, conoscenti o amici, dei
quali stimano il giudizio; pur sapendo con ciò d’essere quasi
sempre ignorati da quei compilatori di gazzette e antologie che, come
gazze ladre, vengono attratti solo dal luccichio. Onesto e rigoroso fino
all’intransigenza, Alessandro aveva un rispetto di sé e della
propria integrità così alto e fermo da consentirgli solo
brevi lettere a rari amici. Se a quelle lettere allegava qualche poesia,
non s’aspettava di più di un veritiero giudizio. Ma, come
scrisse Anceschi di Baudelaire, Ricci «fu ciò che fu perché
così volle essere, e si aiutò con tutti i travestimenti
calcolati, le studiate macchine che gli fu possibile inventare».
La scelta della disperazione, il prepararsi da sé consapevolmente
le trappole in cui cadere, il mettere in mostra i motivi della propria
esperienza di autoflagellazione, furono i segnali trasparenti dell’intenzione
di assecondare il proprio destino. La sua impresa fu quella di dare forma
all’angoscia e alla disperazione, consapevole che tutto debba esserle
sacrificato. E chiunque – anche non conoscesse i due precedenti
libri pubblicati in vita: Le segnalazioni mediante i fuochi (Piovan
Editore, 1985) e Indagini sul crollo (Edizioni del Leone, 1989)
–, chiunque, dicevo, leggerà I cavalli del nemico
(Il Labirinto, Roma, 2004), libro postumo (approntato da Ricci prima che
la malattia gli togliesse tempo e forze), ne sarà persuaso.
La peculiarità della poesia di Alessandro Ricci,
ha scritto Fabio Ciriachi («l’Unità», 14/7/2004),
«non è nello sviluppo per crescita ma nell’accumulo,
che in termini creativi corrisponde alla difficile arte della variazione».
È vero. «Ogni anima bassa / come quella che ho scrive non
una, / ma due al massimo / cose buone, poi le ripete / male e in fine
/ la smette, senza avere / vissuto mai», leggiamo ne I titoli
degli altri. Pochi temi, gli stessi della grande poesia di sempre,
ripetuti e variati; sì, ma da grande poeta. Il primo è quello
della morte. La morte, stella fissa della sua poesia, a cominciare dal
suicidio del pompeiano Furio Seniore, in Le segnalazioni mediante
i fuochi, per finire con quello di Protadio, in una memorabile scena
di De Reditu, passando qui per le morti di Guido, di Lucrezio,
di Giuliano l’Apostata, e in tutte figurando l’immaginata
sua o quella stata del genitore, ogni volta ricordata e risofferta. In
De Reditu c’è un breve colloquio fra Rutilio e il
nipote: «È il pensiero della morte che aiuta a vivere»,
dice Rutilio. «Sembra un pensiero cristiano», gli risponde
il nipote. E Rutilio ribatte: «Sembra, ma non lo è».
Ciò spiega perché le macchinazioni (penultime le
chiama in un bel titolo) del suicidio fossero per Ricci come uno scongiuro
e ne alimentassero il male di vivere, perciò la poesia. In Eccoti
il regalo per il tuo quarantacinquesimo compleanno scrive: «Sarà
basta / per dire basta il tempo che ti avanza, / e poi basta», perché
«la vita è un posto dove si può / essere felici. Ma
quando l’odio / passa dagli altri a se stessi, allora / è
finita». Non c’è niente di cristiano, o di religioso
in senso stretto, nella sua poesia; anzi c’è la fierezza
di un pensare laico nudo e senza infingimenti, rivendicato fino all’ultimo
con severa consapevolezza e in ultimo incarnato nella straordinaria figura
di Giuliano l’Apostata che, pur sconfitto dagli ormai «molti,
folli galilei», reca un estremo messaggio di virile accettazione
della morte, della morte che tutto chiude. (Come non ricordare a questo
punto le discussioni con Alessandro sul modo migliore di passare «da
vita a morte / senza dolore»? O come dimenticare la pazienza con
cui egli, quando è venuto il momento, ha saputo affrontarla quella
morte sempre corteggiata? E leggendo i versi con i quali Giuliano morente
si rivolge agli amici che gli sono accanto: «Lo so, siete ancora
/ troppo viventi, non potete / seguirmi, grazie / lo stesso», chi,
tra quelli che negli ultimi mesi andavano a trovarlo, non vi sente l’eco
delle sue parole quando diceva: «Ora vai, sarai stanco», o
quando pregava: «Non venite, perché mi emoziono»?).
In una delle prime poesie del libro, La seconda volta sul tunnel,
leggiamo: «Penso alla gioia sgomenta e / forsennata d’esser
protagonista / dei gridi, il cuore roco che si / spalanca e riflette nei
contatti / di dita, nelle strette e poi le / fughe, per venir presi di
nuovo, / toccati per sempre.» E più sotto: «Il vecchio
che risoffre / la fine del pomeriggio di gloria, / gonfia primavera di
chi vive / altrimenti nel buio stavolta / sono io, la ruota gira.»
Siamo subito nel vivo del libro. Difatti, a questi versi seguono due grandi
poesie. La prima, 1974, 1984, già inventario e bilancio
di ragioni e sentimenti, nella quale, a immagini virili di morte, alle
immagini dei «maggiori fratelli» Ricci sa di poter contrapporre
solo la propria dignità, che amore e solitudine tendono a vanificare.
L’altra, È vero come, che?, in un tempo universale
«di praxis» e «di svendita dell’inutile»,
chiude un tempo personale della vita fatto spesso «di promesse non
enunciate, di incontri non / avvenuti»; come altre, precedenti e
successive, nasce dalla delusione di un amore andato a male: la consolazione
viene solo dal lontano passato, dagli «incanti di Socrate e Platone»,
«greci di dolci parole» ch’egli sente più vicini
di tanti contemporanei, e dai loro «remoti, luminosi pensieri»,
perché il presente, «l’attimo immobile, atteso / e
temerario» della poesia successiva, riserva solo desideri di morte,
lascia solo la voglia di «strabere / il mare, perdere i sensi, /
affogare».
La passeggiata, poesia che da sola costituisce la seconda parte
del libro, è un paradigma. «Sali di qua» leggiamo all’inizio,
«senza / sentieri, senza senso, solo / col sentimento». E
più sotto: «Se non lo fai oggi, / non lo fai più.»
La passeggiata («Con chi la faccio / (…) quale ombra / della
memoria m’accompagna?» Ricci si chiede), la passeggiata solitaria
da Monte Grosso alla Cresta Bruciata dell’Inferno, e lungo il crinale
del Mindino, fino al ritorno a Garessio, «sua patria»;
la passeggiata nei luoghi amati è occasione per distillare dai
ricordi dell’adolescenza ennesime riflessioni sulla propria vicenda
(parola chiave, questa, se ne ripensiamo l’etimologia); motivo per
domande banalissime e cruciali: «M’avranno dato il trasferimento?
/ Vendo casa? Rifaccio / una visita di controllo?»; fonte di vaghissime
speranze e sentimenti di precarietà: «Vivere decenni oscurando
la luce, facendo / d’ogni estate un autunno e d’ogni autunno
/ un inverno», scrive in versi che rivelano il senso bruciante d’aver
sbagliato tempo, il tempo della fisica e quello della linguistica, insomma
della logica (poco prima aveva scritto: «Sono un individuo privo
di tempi verbali»). Poi, ecco la nostalgia di Roma, la città
del padre e sua, pur se evocata attraverso l’immagine dei poeti-dicitori
che si credono belli, «nel massimo della vampa» della sera
estiva. Finché, nella maggior fatica, quando comincia la «sfogata
discesa» della strada e della vita, non gli resta che provare «a
illudere il percorso» con l’amata figura femminile cui confidare
il proprio «umanissimo credo a niente», quando la
passeggiata sta per finire e si è a pochi chilometri da casa: «dove
nessuno m’aspetta», conclude.
«Arrivo dove nessuno mi aspetta»è anche l’inizio
della terza parte del libro. «Mi aspettano la città di mio
/ padre e lunghe passeggiate / con lui che è morto», prosegue.
Così, la passeggiata paesana si salda perfettamente alle passeggiate
cittadine, dolenti, itineranti elegie della nostalgia, con al fianco l’ombra
del padre evocata in situazioni e tempi diversi: nella bellissima, già
citata Eccoti il regalo per il tuo quarantacinquesimo compleanno
in un agosto vuoto, di «troppi / morti, troppe perdite e lontananze»;
altrove, in Poco dopo alcune, sciupate voci, «nel digiuno
prandiale d’una domenica / di dicembre», quando «il
suono di anziane voci» suscita il ricordo di un altro «lontanissimo
/ pomeriggio finito male»; in Case, ristoranti, giardini e scale,
in una notte d’inizio novembre, dopo un’ennesima, delusa speranza
d’amore, col coraggio estremo del «parlare chiaro» tipico
di Ricci, «perché / la sconfitta è lunga o non finisce
mai», capace di commozione e di un pianto sommesso ma non pudico,
di bambino. «Caro papà, però / non ho commesso errori,
quasi impeccabile nella piega / amara della bocca», afferma nel
finale, «e girando la testa / per non vedere quegli occhi che poi
/ m’avrebbero perso ho detto proprio le parole / che avresti voluto
/ sentirmi dire: molte eleganti, alcune leali, tutte / inutili.»
Insomma, «com’è naturale che sia», conclude,
con «l’impressione onnipotente di avere torto, di avere perso»,
sopraffatto dalla «furia / pacata della bellezza», come scrive
in 4 aprile 1990.
Fra i vagabondaggi con «il fantasma del genitore» nei luoghi
dell’infanzia e le discese del tempo, là s’insinua
la furia pacata della bellezza, che non è della città (o
non solo, naturalmente), ma della donna amata, della donna che incanta
e inganna, che lusinga e si nega, punendo ogni forma di desiderio.
Esaltazioni e delusioni amorose sono brucianti: «oggi ho portato
il mio amore sul ciglio / di un baratro; più tardi, su una scala
/ d’oro: assedio al desiderio, aumento / di pugnali e tenerezze
sono ogni ascolto, / ogni sguardo passati», scrive. E ne I titoli
degli altri spiega: «alle tre / la polacca di nome Ela / invaderà
l’osservatorio, i palazzi / di fronte, i rumori / del traffico,
i gridi / delle rondini, il cielo e il mare, / con la sua giovinezza».
Eccolo, il segreto: la giovinezza. Come sfuggirle? Come non cederle o
ammettere «altro tempo, altro spazio, altro / incanto che quelli
vissuti insieme»? Ogni conquista perciò è una «vittoria
gracile» e ogni rifiuto o abbandono «sconfitta potente»;
solo conforto possibile le «condivise bellezze, / le vere e le vane»
della poesia omonima, o l’amicizia, se ancora «alcuni ti amano,
/ non tutti dimenticano». In fondo, i suoi innamoramenti non erano
che auspici, esaltazioni dell’attimo presente, personale carpe
diem o puntura che «separa la ragione / dal sogno, l’una
condannata al tempo / che va, l’altro fermo per sempre / nell’esultanza».
I suoi versi «d’amore e incanto», poco sentimentali
ma pieni di sentimento, umanità e consapevole, dignitosa accettazione,
scritti in una lingua media e colloquiale, si presentano disarmati, indifesi,
platealmente arresi alla derelizione d’ogni straziata bellezza.
E le poesie che narrano il percorso rovinoso dai gradini d’oro alle
profondità del baratro, le elegie dell’amore deluso sono
spesso fuor di metafora e di grande impatto emotivo, ma non perciò
prive di sapienza tecnica. La prima di esse, Avvitamenti e terrazze,
ne è prova e dimostrazione: qui forma e soggetto sono specchiati,
perché i versi mimano la vertigine di un pensiero risentito e intransigente
che s’avvita su se stesso e che s’arresta solo un momento
nella fissità dello sguardo per «l’ingerenza improvvisa
di qualche / sgangherato desiderio carnale / che s’imbuca nelle
braci dell’ascolto / come disattenzione» e forse vanifica
il «programma suo», della donna, «di congelarmi»,
dice Ricci, il cui commento, subito dopo, è amaro, ironico e straziato:
«perché niente, / niente è più facile e divertente
/ che finire il cavallo stramazzato…»; il paragone che segue,
fra volontà di farsi male e inconsapevolezza della riuscita, è
esemplare: colei che colpisce lo fa «con lo stesso / sguardo ammaliato
dei ragazzini di tutti / i tempi» che facendosi largo nel cerchio
degli adulti osserveranno «lo spettacolo inebriante» del cadavere
del nonno, «prima o poi». Di nuovo il divertimento per il
cavallo caduto? «E allora è chiaro», è la conclusione:
«l’incanto è falso». Anche in Quasi un’interezza
la versificazione è di una spirale che scende, scende e taglia
il tempo e lo spazio di una mattina d’agosto, «esemplare come
nei versi di greci e stilnovisti», Ricci precisa con una similitudine
trasparente delle sue; una mattina che scade nel decèdere, nella
«foga del macello» e di «una pura stanchezza»,
in un avvolgente «nulla ricolmo, affollato di lei». «Così
mi tocca questa donna per sempre», conclude, «nei luoghi dove
la mia vicenda, / così sporca d’errori e disdette, / ora
paga e s’arrende». Perché «il lungo processo
ai danni di se stesso», come avevamo letto altrove, «ha un
esito di condanna». Che parli a fare a Polimnya, nella Centrale
Montemartini? regala subito la perfezione di una prima strofe bastante
a se stessa: «Come al pesce goloso che addenta / l’esca che
l’uccide / ma non lo sa, / ciò che la ragione toglie all’attesa
/ il cuore lo dà»; se non fosse l’inizio di un altro
carme della delusione e del disinganno. La terrazza, infine,
è una bellissima elegia in minore che sanziona l’addio alla
casa della vita, e forse alla vita stessa come fino ad allora vissuta;
lo fa nominando i piccoli oggetti d’affezione quotidiana, testimoni
negli anni di così tanto amore e dolore che è strano lasciarseli
alle spalle o perderli a un tratto quasi con indifferenza, in un «oggi»,
leggiamo, «che rifinisce come sempre / nel buio ma non importa,
a questo punto, / forse, gran che: sì, proprio, che importanza
/ può avere.»
Dove la lingua si fa tagliente, perché lucida precisa affilata,
è nelle poesie che sono ai vertici del libro. In Ipotesi su
Cavalcanti, in cui si può leggere tutta la delusa speranza
di Ricci di vivere la propria morte come immagina quella di Guido: «un
termine di bellezze», entrando, Guido a Firenze, egli nella sua
Garessio «con la testa alta e disfatta / di fantasma, perché
un poco / agli astanti – fossero amici / o avversi – almeno
/ importasse l’aspetto fiero / se non l’anima disperata»;
solo un grande poeta sa dire in modo così preciso quel che ancora
non ha sperimentato ma che sa vero. In Una storia come le altre,
discesa del tempo per descrivere lo sfinimento di Lucrezio che, sorridendo
di tutto e «dell’esito inutile dei versi», ma senza
ridire «un solo difetto del mondo», s’abbandona serenamente
a «l’assenza totale del desiderio e della pena»: la
morte.
Al gruppo appartengono anche le grandi poesie allegoriche nelle quali
i temi maggiori del libro sono trasfigurati in potenti invenzioni di figure
relitte e solenni. Penso alla nave nera di Melanìe, alla
carretta dei laghi di Mare d’Aral. Penso in particolare
a I cavalli del nemico, la poesia che dà il titolo al
libro; a quei cavalli nei quali Ricci rappresenta le donne, tutte le donne
e quelle che amò e che non lo seppero amare. Sì, le donne,
loro, i cavalli del nemico; e se di qualcuna, più lontana nel tempo,
ricorda «la furia e la destrezza nelle prime / fasi della battaglia,
la velocità / delle fughe e i reiterati / assalti. E le ferite
leggere / che gli avevano inferto: pochi graffi / quasi rimarginati, se
non proprio / invisibili», furono però le ultime due (forse
le stesse «giovani donne che non / l’avevano amato, volate
/ di volo azzurro ogni volta che le / guardava» nominate nell’ultima
grande poesia del libro, La sera), furono loro «a colpirlo
nel petto»; da esse, descritte quasi con tenerezza, in fondo con
affetto, era partita «l’asta a due punte / che l’aveva
trafitto». Infine penso all’ultima parte del libro, Morti
parallele, alle sei poesie che compongono il ciclo di Giuliano l’Apostata,
l’ultimo grande personaggio e lontano sosia del poeta scrivente.
Morti parallele è la definitiva discesa del tempo, nei giorni
antichi o antichissimi della sconfitta di Giuliano l’Apostata ad
opera dei persiani. Qui si compendiano tutti i motivi e tutte le suggestioni,
si sintetizzano ideali e disillusioni: fedeltà a se stessi e al
proprio modo di vivere, condivisione di un destino o della sorte, l’amicizia
e il rispetto, la storia grande o minuta che a tutto e a tutti pare sfuggire
e farsi senza logica, l’inno e l’elegia, in un alternarsi
di gelo e fuoco, le stupite domande di Massimiano, che non sembrano trovare
risposte, e, infine, la risposta di Ammiano che, quando finalmente giunge,
si rivela disincantata e persino banale, ma che sintetizza tutto, tutto
prima della battaglia finale, dove protagonista, comparse e figuranti
troveranno la morte. «Perché dovremmo / temere ciò
ch’è stato deciso?» chiedeva Massimiano. Ma davvero
qualcuno decide per noi? Vetranione non lo crede. Egli va, «chi
lo sa perché / (…) / dove Giuliano va, nel mezzo della disfatta».
Anche Alessandro Ricci.
«Capoverso», 11, gennaio-giugno 2006
|