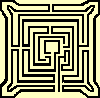|
Recensioni
UN CATULLO ROMANESCO
di Francesco Dalessandro
«La lingua più sintetica dopo il latino è il romanesco».
Quest’affermazione così perentoria si legge all’inizio
della nota di traduzione che accompagna e chiude questo curioso e bel
libriccino: Vivemo, Lesbia mia, famo l’amore, con il quale
Ottavio Sforza si è cimentato in un’impresa audace e ad alto
rischio di fallimento, ma perfettamente riuscita, cioè quella di
«arivortà in romanesco» alcuni carmi di Catullo.
Nel corso della nota, il nostro traduttore esemplifica convincentemente
il perché, secondo lui, il romanesco raggiunge il massimo della
concentrazione con il minimo sforzo, ovvero con il massimo risparmio.
Scrive: «Il romanesco non è un’alterazione dell’italiano,
è una continuazione del latino. Consideriamo. Semo è
più vicino a sumus che non siamo; come la prima persona
sò rispetto a sum, da cui è così
lontano l’italiano sono... Solo a Roma echeggiano ancora
parole radicalmente latine come l’avverbio mo (da modo),
e chi si è mosso per le sue strade dirà sò ito...».
Gli esempi più appropriati, però, sono nei testi stessi
delle traduzioni. Il raffronto con l’originale darà subito
ragione di quanto detto se ci soffermiamo, ad esempio, su alcune scelte
davvero felici, come il metti scorza che traduce l’obdura
latino del carme Miser Catulle, desinas ineptire; oppure come
chi ama ama de più, ma er bene scenne che traduce uno
dei versi più belli e terribili di Catullo: cogit amare magis,
sed bene velle minus, l’ultimo del carme Dicebas quondam
solus te nosse Catullum. È però nel confronto con le
traduzioni italiane in circolazione che la dimostrazione acquista forza.
Per darne qualche esempio ho scelto il carme Ille me par esse deo
videtur (traduzione di una traduzione, o, per meglio dire, dell’imitazione
di una ben nota poesia di Saffo), uno dei testi dove meglio si dimostrano
la capacità interpretativa e la fedeltà all’originale
del nostro traduttore.
Leggiamo la poesia nell’originale latino: Ille mi par esse deo
videtur, / Ille, si fas est, superare divos, / Qui sedens adversus identidem
te / Spectat et audit // Dulce ridentem, misero quod omnis / eripit sensus
mihi: nam simul te, / Lesbia, aspexi, nihil est super mi / [Vocis in ore]
// Lingua sed torpet, tenuis sub artus / Flamma demanat, sonitu suopte
/ Tintinant aures, gemina teguntur / Lumina nocte.
Ed eccone la versione in romanesco: Me pare che dev’esse paro
a un dio / e puro più de ’n dio, si se pò dì,
/ quello che sta de fronte a te e ’gni tanto / te guarda e sente
// che ridi dorce, e io ce perdo i senzi /pover’a me, ch’abbasta
che te vedo, / Lesbia, e nu’ m’arimane manco ’n filo
/ de voce in bocca, // ma la lingua s’addorme, come ’n foco
/ me córe dapertutto, un gran ronzio / ne le recchie arisona, e
m’aricopre / l’occhi la notte.
Mettiamo a confronto questa versione (che del resto – come racconta
il traduttore stesso – nasce dal disappunto suscitato in lui da
un pessimo precedente, che non cita, ma che è facile indovinare
quando si sappia che uscì da Einaudi diversi anni fa), con le altre
tre in lingua reperibili in libreria. Non potendo riprodurre integralmente
queste ultime, mi limiterò a qualche esempio cruciale. Vediamo
come viene tradotto l’inciso al secondo verso: si fas est,
che alla lettera vuol dire: se è consentito, se è lecito.
Enzo Mandruzzato, la cui traduzione, per la B.U.R., ha in comune con questa
di Sforza il metro: strofe di endecasillabi chiuse da un quinario (ma
l’economia della lingua, come la corrispondenza di significato delle
parole romanesche con quelle latine, è a tutto vantaggio di Sforza);
Mandruzzato, si diceva, interpreta, perciò traduce quell’inciso
con: se dirlo non è colpa; addirittura un settenario:
sostanzialmente corretto, ma, a mio parere, eccessivo nell’economia
del testo. Tiziano Rizzo (Newton Compton) traduce la stessa espressione
con: bestemmio, sintetico ma anch’esso eccessivo, stavolta
nel senso. Mario Ramous (la cui traduzione, per i Grandi Libri Garzanti,
fra le tre è, in generale, quella più riuscita), traduce
con: vorrei dire. Sforza, l’avete letto, traduce: si
se pò dì, che mi sembra la resa più esatta.
Un altro esempio. Il finale della prima strofe e l’attacco della
seconda: Spectas et audit // Dulce ridentem, viene tradotto da
Ramous con un prolisso: gli occhi fissi / t’ascolta ridere //
dolcemente. Rizzo se la cava con un poco convincente: si delizia
e ascolta // dolce te che ridi. Mandruzzato, infine, è preciso
in: ti guarda, e ascolta, ma non lo è altrettanto in:
e tu sorridi con dolcezza, un inutile allungamento. Ricordiamo
come ha tradotto Sforza: te guarda e sente // che ridi dorce:
massima concentrazione, massimo risparmio.
Ultimo esempio. Il finale: gemina teguntur / Lumina nocte. Mandruzzato
traduce: l’ombra si moltiplica / davanti agli occhi, che
non mi pare granché preciso. Rizzo: diffusa notte / ottenebra
gli occhi. Ramous: su questi occhi / scende la notte. Sforza
ha tradotto, invece: m’aricopre / l’occhi la notte,
con una precisione e un’esattezza che direi esemplari.
Per finire, mi accorgo ora, rileggendo gli esempi fatti, che se anche
non fosse il romanesco ma l’italiano, la lingua di questa traduzione,
essa sarebbe ugualmente esatta, precisa, economica; il che, in fondo,
sta a dimostrare l’assoluta bravura del traduttore.
«il Portolano», XV,
58-59, luglio-dicembre 2009
Gaio
Valerio Catullo è nato a Verona intorno all’84 a.C.
e morto a Roma all’età di trent’anni. La sua opera,
come ci è stata tramandata, comprende 116 componimenti di metro
vario che alternano amori e odi, tenerezze e invettive.
|