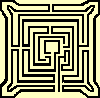|
L’io
non esiste
Il libro
Videoclip
Notizie sull’autore
Gianfranco Palmery
Dello stesso autore
Mitologie
Sonetti
domiciliari
Gatti e prodigi
Giardino
di delizie e altre vanità
Medusa
Il poeta
in 100 pezzi
In quattro
Divagazioni sulla diversità
Italia, Italia
Profilo di gatta
Amarezze
|
Recensioni
del libro L’io non esiste
di Gianfranco Palmery
SE L’IO NON ESISTE
di Marco Caporali
Ironia è provvidenza, nella coazione ad osservarsi
scrivere, come si osserva il comico discendente, senza eredi, di un’illustre
e tragica genia. Nell’ultimo libro di Gianfranco Palmery, L’io
non esiste, la sola possibile fede è in quella spoglia ininfluente
di una grandezza decaduta che ha nome poesia. Fede per via derisoria,
nella forma dell’autodenigrazione, laddove coincidono osservatore
e osservato, carceriere e recluso. Eppure, nonostante l’involuzione,
il mondo in virtù della poesia, sottraendosi all’informe,
al caos e all’arbitrio, diviene intelleggibile e dicibile.
Il culto della poesia, in Palmery, concerne la misura delle cose e la
propria interna misura. Ed è proprio lo scagliarsi con le armi
del pensiero contro l’oggetto del proprio amore, per poi di nuovo
dichiararsene devoto, un segno peculiare di questo autore quanto mai discosto
dalle correnti del tempo, pur non potendo eluderne l’assedio. Se
la città è simulazione di un fare, attiva inattività,
la poesia è principio d’ordine, dimora, sorgente di senso.
Nella logica stringente dei versi, nel cerimoniale che rinnovandosi garantisce
la sopravvivenza, quel che appaga è l’implacabile senso, mai
derogabile, con un rigore e una chiarezza che nulla concedono ad avventure
di per sé appaganti.
Sonetti domiciliari è il titolo di una sezione del libro
(già pubblicata in autonomo volume, con qualche differenza rispetto
alla versione attuale) dove domestico è il restringimento delle
titaniche aspirazioni, nell’irrisione di sé praticata da colui
che subisce lo smacco, il personaggio agli arresti, chiuso nelle sue ossessioni,
quotidiane operazioni, manie senza grandezza.
Non è un buon tema il mal di fegato, male
titanico, per dei versi domestici,
domiciliari, anche se agli arresti
non vuol dire incatenato a un crinale
di roccia con la rosura del fatale
avvoltoio che si avventa e dai suoi resti
roseo rinasce il fegato immortale;
qui i tormenti sono oscuri modesti:
[...]
6 – Prometheus Housebound
Nobiltà e degradazione sono due facce della stessa
medaglia. Se la cella ha valore planetario (dal cervello all’universo),
esiste un prima non consumato in sonnamboliche deambulazioni di stanza
in stanza nella casa di pena? Ci fa rispondere affermativamente il demone
che un tempo era angelo, e che potrebbe ritornare ad esserlo. C’era
un tempo prima dell’ipnosi e dell’incantamento. Tale tempo,
in cui era dato incontrarsi, è concluso, in senso sia biografico
che cosmico (il tiro è sempre doppio). Un tempo autentico, che
non conosceva la coatta inesistenza dell’io, dove il sonno era sonno
e la veglia veglia, scandito da inizi e da fini, non dal ciclo perenne
della finzione.
La caduta è nell’assenza di un presente, condannato a sparire
compiendosi. Registrati sul foglio, i nostri atti, e i pensieri che li
riflettono, denunciano la loro inesistenza. La poesia, «forma del
niente», è un funereo rito di passaggio, un «rito acheronteo»
di cui il lettore è complice, come vien detto nella poesia che
conclude i Sonetti domiciliari. Sonetti che alternano il grave
e il vivace, così come le poesie della sezione eponima,
in un’opera dal respiro sinfonico, in cui si orchestrano movimenti
che evidenziano ciascuno una diversa e analoga coazione nell’inesistenza.
Il nome, la casa, la città, l’io, il sonno, sono varianti
della medesima cella. La poesia, in principio «paziente» ed
infine «perfetta» giardiniera, sistema e dirada ma così
facendo, curando e creando il giardino, al suo interno reclude. Giardiniera
e carceriera, mentre salva ci danna. È ciò che ci fa fuoriuscire
da noi e che a noi riconduce. È l’illusione disattesa di potersi
liberare dal falso involucro dell’io e riacquisire verginità
mediante un rito di purificazione. O un rito di autocannibalismo, dove
il prezioso amuleto, puro e impuro, sacro e profano, tragico e comico,
mostra il suo risvolto macabro. Il sublime si spegne nel grottesco e nell’autoannientamento:
contro di sé rivolti, ci si riduce a brani.
La vanità del cercarsi, l’impossibilità di appropriarsi
di sé, di approdare a qualcosa che non sia provvisorio e intercambiabile,
sono condizioni dell’essere pensante e della modernità. Compiendo
un ulteriore passo, oltre lo sdoppiamento e la moltiplicazione dell’io,
Palmery aggredisce dall’esterno l’io individuale, provando che
«dietro la pienezza della sua pronuncia singola non c’è
che il vuoto plurale» – come spiega egli stesso nella Premessa.
Non siamo che forme cave occupate da un abusivo, da un presunto generatore
di identità.
[...]
chi dice io? – Miriadi di io...
Io è mille – mille sono io:
che cosa c’è dietro questo stridio?
Io sono
Se all’io si deve la differenza rispetto al resto
del mondo animato, discutibile è la supposta diversità umana:
Chi ti svanisce, che ti arde in fondo? Tutto
ti si confà, e la famosa solfa
«non so chi sono, non sono chi sono»:
la musica del merlo è forse diversa?
e il topo squittisce su un altro spartito?
[...]
Taccuino degli incubi
Punto di partenza e d’arrivo, nel cerchio chiuso
del libro e delle cose, è l’inesistenza dell’io. Per
cui il libro può essere letto come percorso dimostrativo di quanto
viene postulato nel titolo. Ma una volta accertata l’inesistenza
di quel che era dato per irremovibile, di quel che era posto a garanzia
dell’esistenza, si resta vuoti, deserti, perduti. Venuto meno il
despota, lasciati a se stessi, quel che resta è provare a ricordare
il suono della sua voce, il suo respiro,
il tempo – il benedetto tempo che dava
ai miei giorni abitandomi, il suo battito
che diventava passo, polso, mio respiro –
per imitarlo, rifarlo, come si cerca
d’evocare una voce amata morta modulando
la propria voce a quel ricordo: delirando.
«Pagine», XV, 41, maggio-agosto 2004
L’IO NON ESISTE
di Idolina Landolfi
Ogni poesia è sempre postuma, come scrive l’autore
nella premessa a L’io non esiste: e in ciò sono
con lui, soprattutto perché un’opera come questa, di grande
efficacia nella compattezza delle sue modalità, nell’andamento
egregio della versificazione, ancor più mi conforta nel mio convincimento.
La vera poesia è sempre postuma. Nel senso – qui appunto esemplato
– d’un distacco che si fa spesso vera e propria «uscita
dal mondo», contemplazione a limine del vuoto spazio della
memoria e dell’io. «Vorrei solo osservare il transito / quieto
delle nuvole come un astronomo / le sue costellazioni» è
l’incipit di squisita musicalità di Studio delle nuvole,
nella prima sezione del volume. Cui seguono i quarantadue Sonetti domiciliari,
insieme che rimanda al concetto degli arresti domiciliari: poesia carceraria,
appunto, di un volontario seppellito vivo, ossessionato dal «rendere
l’osservatore il suo oggetto». Poesia domestica, anche vero
e proprio diario in versi del Prometeo in sedicesimo dagli umori atrabiliari,
che vi registra la graduale scomparsa dell’io, fino all’effusione
di esso – e della sua diretta emanazione, la scrittura – in
nero fumo. Alla tormentosa fobia del «fuori», che nonostante
l’assoluto isolamento giunge con l’eco sorda dell’Italia
delle «anime morte», corrisponde la minuziosità e il
silenzio di gesti sempre uguali, «giorno di recluso che inferma»
in un tempo incantato e circolare, e l’esercizio della scrittura
sempre più simile ad un «rito acheronteo». Perché
sovente (né potrebbe essere altrimenti), l’interlocutore del
lungo monologo è la propria poesia, esecrata, definita inutile,
oppure invocata quale «paziente giardiniera» del «groviglio
dei pensieri». L’autore si appiglia ai momenti di lavoro, alle
carte sulla scrivania illuminate dal piccolo astro della lampada; o descrive
la sua poesia come già trapassata, che ormai gli compare solo in
sogno come altri volti di morti. Per quelle «notti incantate»
è il rimpianto, per quei «carmi carcerari» di cui resta
solo una fantasmatica traccia sul soffitto della cella.
«La Sicilia – Stilos», VI, 48, 21 dicembre
2004
L’IO NON ESISTE
di Giancarlo Pontiggia
Fra le piccole case editrici di poesia, spesso sostenute
dalla sola passione, una passione autentica vissuta nel segno della purezza
e della fedeltà, spiccano da anni, per la cura della veste grafica
e la qualità delle scelte poetiche, le edizioni «Il Labirinto»
di Roma; due sole, esigue, ma folgoranti, le collane: «Stanze»
(titolo che richiama un’idea di rigore formale – le stanze
di una canzone – ma anche un luogo protetto, che vuole essere il
luogo della poesia stessa) e «Tarsie» (destinata a testi più
brevi: tessere di intensa forza simbolica accompagnate da disegni originali
di artisti). Alle «Stanze» appartiene l’ultimo lavoro
di Gianfranco Palmery, L’io non esiste, preceduto da due
dense paginette di poetica che illuminano il senso del titolo e del libro:
«Che un poeta dica io o tu o dica polimetis Odisseus o
our ancient friend Don Juan: tutto è invenzione: l’io
non esiste – se non al pari di ogni altro eroe, come veridica menzogna,
maschera solenne o ironica, patetica o tragica». La poesia sgretola
insomma, secondo Palmery, «il tetragono io individuale», esce
dalla contingenza per tracciare forme di più alta, forse impossibile,
necessariamente impossibile si dovrebbe aggiungere, bellezza. Ma questo
io che informa di sé tutto il libro, questa maschera ironica e
tragica insieme, modellata letterariamente sui versi e sulle prose concitate
di un Hoffmann, di un Poe o di un Baudelaire, e che a volte sembra richiamare,
volutamente richiamare, personaggi romanzeschi quali Des Esseintes, il
principe di Salina, Don Juan aux enfers o un Don Chisciotte ormai
amaramente rinsavito, questo «sempiterno / eroe furioso e martire
– gran ruolo –, / familiare col cielo e con l’inferno»
(p. 34), che sembra uscire all’improvviso dalle fosche fiamme di
un quadro manierista o prebarocco, chiuso nelle sue stanze romane come
un recluso, dedito ai suoi strenui, rovinosi esercizi poetici, «trucchi»
(p. 34) da prestigiatore forse, in attesa che si riveli il Grande Nulla,
che le «fate tenebrose» (p. 33) recidano una buona volta il
filo della vita, questo io pallido e paradossale, perduto fra gli specchi
e i nomi di una tradizione giunta ormai al suo luttuoso capolinea (e forse
per questo mai come ora percepita così grande), intento ad una
lotta vana con il mondo degli uomini (una lotta tanto più vana,
dal momento che nessuno, ed è questo, forse, il maggior segno d’eroismo,
se n’era mai accorto), questo io ormai già «perduto,
morto» (p. 49), assediato dallo spleen e dal sentimento
della fine, costretto ad annotare un suo privato Taccuino degli incubi
(«mio archivio / di tenebre», p. 95), che può sognare
soltanto morti (p. 45) – questo io così in apparenza déjà
vu ha una sua tale potenza d’impressione, una sua così
visionaria radicalità, e soprattutto una così solitaria
e acuta consapevolezza, immediatamente tradotta nel corpo liquido dei
versi in sentimento e in fulminea percezione visiva, dello stato dei tempi
in cui abitiamo da accamparsi memorabilmente nell’immaginario dei
suoi lettori. Non è paradossale, del resto, e la storia ce lo ha
spesso insegnato, che siano proprio letterati apparentemente chiusi al
mondo, reclusi volontari nella cella delle loro private ossessioni e di
squisiti segni estetici (la bellezza che talvolta salva, che spesso ci
perde: il «ricco nulla» in cui il poeta scompare «lentamente,
e in silenzio», di p. 23) a fotografare con più esattezza
quella realtà che pure li disgusta e li obbliga a un’esistenza
fallimentare e nascosta. Certo questa Roma infernale (p. 69) – dove
unici segni che si sottraggano all’esibito niente della
vita feriale sono quelli di un «nero angelo» (p. 87), o la
stridente musica «degli antifurto degli allarmi delle / ambulanze»
(p. 63), – questa Elsinore dedita solo a lussuria e a delitto (p.
62), «mondo di eccedenze: maceri / e macelli» (p. 69), luogo
di una protesta metafisica che filosofia e giornali hanno già da
troppo tempo liquidato, non sarebbe altro che una vana ostentazione di
decadente percezione della fine se non fosse sostenuta, oltre che da una
lucida e tormentata sensibilità linguistica (sfolgorante, per la
raffinatezza degli impasti, il vocabolario poetico), dalla retorica lussuosa
e splendida, dallo straripante movimento del ritmo e delle immagini, dal
fasto degli accumuli baroccheggianti (si vedano poesie come I ricordi;
Penso ai pettini, alle garze, alle bende; Ed altro ancora
resta fuori, resiste), dai frondosi festoni di allitterazioni e di
rime (una vera gioia – per la loro tagliente misura – degli
orecchi e della mente), dalla sontuosa rifondazione della forma-sonetto
cui assistiamo pagina dopo pagina con lo stupore di chi riscopre, finalmente,
dopo tanta antipoesia, dopo tanti sciatti versi liberi degli ultimi decenni,
una profonda, liberatoria idea di ciò che era, ed è, letteratura
(quella letteratura senza la quale la poesia non sarebbe altro che vaniloquio,
perso sfoggio di bei versi casualmente dispersi da una sibilla impazzita).
Se compito della poesia, come recita una delle poesie più felici
del libro, sarà dunque quello di tagliare, sfoltire, mettere
ordine «nel groviglio dei pensieri, in questo / gran disordine
dove ogni pensiero / si ripete si perde come in un assedio / di erbe che
si fanno presto sterpi / tra loro soffocandosi [...]» (p. 82), al
poeta non sarà dato altro che restare fedeli, fino in fondo, al
proprio «cruciato perditempo» (p. 13), consumando il «tempo
senza tragedia / in calmi studi, mentre il mondo rovina» (p. 63).
da «Testo», XXVI, 49, gennaio-giugno 2005
|