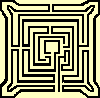| Giardino
di delizie
Il libro
Videoclip
Notizie sull’autore
Gianfranco Palmery
Dello stesso autore
Mitologie
Sonetti domiciliari
Gatti e prodigi
Medusa
L’io non esiste
Il poeta in 100 pezzi
In quattro
Divagazioni sulla diversità
Italia, Italia
Profilo di gatta
Amarezze
|
Recensioni
del libro Giardino di delizie e altre
vanità di Gianfranco Palmery
LE VANITÀ DI PALMERY
di Edoardo Albinati
Pensiero minore su Charles Baudelaire e I fiori del
male. Abbiamo il paradosso del poeta probabilmente più difficile
degli ultimi secoli – assai più arduo, nella sua sintassi
grandiosamente sistematica, da pensatore classico, dei frammentati poeti
novecenteschi, spesso assai meno oscuri ed eraclitei di quanto si vorrebbe
credere – il quale viene letto soprattutto durante l'adolescenza
e poi prevalentemente rammemorato, ricapitolato, presupposto.
Come certi monumenti arcifamosi, lo si considera acquisito in visione
una volta per tutte. Etant donné que... Forse sarà
proprio per il suo ruolo colossale, di propedeuta a una modernità
i cui requisiti sembrano in verità evidenti solo a chi abbia già
deciso di metterseli alle spalle.
Oggi l’unico poeta che in Italia pratichi Baudelaire è Gianfranco
Palmery. Lo fa in tutte le forme in cui questa frequentazione bruciante
resta possibile a un contemporaneo senza trasformarsi in uno scacco nobile
o in una parodia. Ciò implica la creazione di un continuum prosastico-poetico
molto laborioso e pieno di rischi perché esige la contaminazione
di tutti i livelli, senza lasciare alcuno spazio franco per la cosiddetta
poeticità, e sfiora di continuo l’abisso del ridicolo, del
ridicolmente abissale, che è poi la materia propria del canzoniere
baudelairiano e l’oggetto misterioso della sua quest. Ragionare
in poesia e ragionare della poesia come se fossero le fasi di un medesimo
respiro richiede infatti una saldezza dell’istituto letterario di
tipo classico, e ciò nell’istante stesso in cui il poeta è
minuziosamente impegnato a dimostrarne l’infondatezza e gli inganni,
quindi obbliga alla fabbricazione (o piuttosto allo smantellamento) della
propria intera vita in vista di tale opera: occhi, ossa, pelle, casa,
lavoro, materassi inclusi.
Il compito è grandioso, e appunto per questo, grandiosamente derisorio
per la personalità che occorre a soddisfarlo la quale non ha senso
definire altrimenti che eroica. Solo l’eroe infatti riesce a parlare
ancora dopo essere stato trafitto e ucciso, riesce a parlare anche da
morto, come fa l’iscrizione tombale al viandante che vi sosta accanto
(suonando infatti spaventosa e comica al tempo stesso, effetto echeggiante
di un «morto che parla», insomma di uno spettro esautorato
eppure autorevole...); e perciò la fonte «postuma»
da cui si origina la sua voce, Palmery l’ha da sempre situata in
un aldilà della vita, in un campo di ceneri calde sul punto di
raggelarsi, di rovine esistenziali su cui già cresce l’erba,
traslando il proprio corpo ossuto di libro in libro in una specie di ininterrotta
inumazione di se stesso, di cui la poesia è appunto il canto didascalico
di accompagnamento funebre, ora struggente di pianto parentale ora stridulo
come la cornetta in un funerale jazz.
Se dunque accettiamo la forma (vuota) di questa dedizione integrale alla
poesia, nella sua mortale mania o maniera di smisuratezza (baudelairiana,
appunto), non troveremo affatto strano il modo frontale con cui Palmery
inquadra i temi o le «stazioni» attraverso cui il discorso
deve necessariamente passare. Inutile nascondersi dietro il fumo degli
interdetti: ciò che non è inesprimibile, suggerisce il poeta,
va espresso (inclusa la figura medesima dell’inesprimibilità);
o meglio va trattato, cioè diventa oggetto assieme di trattazione
e trattamento e paziente trattativa. Dunque: studio, invenzione di equilibri
verbali e fonetici, uso parco o inebriato delle fonti, assemblaggio dei
materiali, rifinitura di concetti e figure, esaustione delle varianti:
come un pittore al lavoro nel suo studio, circondato di utensileria, anche
il poeta deve dare fondo all’intero bagaglio di risorse retoriche,
e la pagina (di prosa o di poesia) ne risulterà alla fine campita
di parole che conservano almeno un po’ la traccia della lavorazione:
perché era proprio questo il fine del lavorare, dare illuminazione
al processo, rischiarare il percorso illustrandone fratture e curve.
Ciò è particolarmente evidente e quasi esibito nella sua
più recente raccolta pubblicata, Giardino di delizie e altre
vanità, la quale si articola come un vero e proprio catalogo
di temi offerti alla riflessione del lettore prima ancora che questi si
accinga a leggere le liriche che compongono ogni sezione: Vanità,
appunto, e poi Preghiere, Virtù, Ospizi, Stazioni,
Inferni...: Palmery immagina la lirica come un «predicato»
su ciascuno di questi inesauribili soggetti di meditazione, (e infatti
non è raro che le sue poesie siano composte di un’unica frase,
di una sola, per quanto ramificata, sequenza sintattica: col risultato
di suonare singolarmente affermative, in qualche modo «positive»
malgrado la tonalità magari sarcastica o funesta), e dunque procede
alla trattazione del tema allineando i risultati del suo «ricercare»
in modo che si crei tra loro un effetto di riverbero, di moltiplicazione,
un’onda patetica che quando cessa di risuonare e si ritira lascia
scoperto un piano del pensiero, per così dire, solidificato e reso
compatto dal trattamento versuale, insomma una filosofia a cui il lettore
è infine libero di arrendersi come di resistere. È un procedimento
al tempo stesso di onestà intellettuale e di antica scaltrezza
retorica: indica coraggiosamente la possibilità che la poesia riprenda
tutto il suo fiato argomentativo, offrendo i saggi di una ricerca individuale
già avanzata («questo io so, o non so, di questo ho fatto
esperimento...»), e intanto s’incamera l’effetto di attrazione
che i temi in sé, proprio in quanto argomenti ben definiti e non
sparse ispirazioni, sprigionavano. Alla maniera di un romanziere o di
un saggista o meglio ancora di un poeta antico, consapevole cioè
della potenza intoccabile che emana dalla materia scelta.
Tale tensione esaustiva che già si affermava nei libri precedenti,
tra i quali citiamo a esempio L’opera della vita (1986), i
Sonetti domiciliari (1994) e il monografico Gatti e prodigi
(1997), trova la sua forma tipica nell’iterazione: iterazione di
concetti e di immagini e di suoni, che si rincorrono tra verso e verso,
poesia e poesia, libro dopo libro, nonché trasversalmente lungo
tutti gli interventi prosastici, contribuendo appunto a irretire il lettore
nel discorso e piegarlo all’ascolto attraverso una serie di finissimi
aggiustamenti. Frequenti in Palmery, al punto da potere essere considerate
la sua «sigla», le sequenze allitterative e appositive tenute
fino alla soglia della maniera e anche oltre (inutile portarne esempi
qui, il lettore ne trova a ogni pagina e spesso anche nei suoi testi in
prosa): più che segnali di un gusto barocco di lusso o di frenesia
linguistica bisognerebbe appunto considerare gli aspetti costruttivi e
suasivi di una tale tecnica, anch’essa intendiamoci «secentesca»
ma sul versante opposto a quello dell’edonismo verbale (Palmery «predicatore»
insomma piuttosto che «giocoliere», fermo restando che anche
uno spirito penitenziale ha bisogno di fiammeggiare sul suo pubblico...).
E altrettante osservazioni, che chiamano in gioco una cultura che si stende
appunto tra l’oratoria grand siècle con accluse Vanitées
franco-fiamminghe e le sezioni purgatoriali dei Fiori del male,
si potrebbero fare sulla sontuosa composizione sintattica del verso di
Palmery (si arriva facilmente a contare una dozzina tra coordinate e subordinate
connesse in un unico periodo!), che si potrebbe dire baudelairiana se
non fosse torturata dall’uso dell’enjambement, volto a romperne
la solennità in modo talvolta quasi irato, talvolta ironico, comunque
sempre alludendo a una pienezza d’arte e metafisica da cui non si
può che, spettacolarmente, con parabola di fuoco e fumo, cadere,
precipitare... essere scacciati, esiliati...
E dunque, anche formalmente e non solo per l’ovvio riferimento tematico,
prima di Baudelaire, John Milton.
Come Milton, Palmery è un poeta di scintille e fumo. Difficile
scaldarsi alla sua poesia, nervina e capricciosa proprio quando parrebbe
consigliare al suo lettore i montaigneschi sollievi della pazienza, i
sorrisi di una luciferina rassegnazione; inutile cioè trattenersi
accanto ad essa sperando di assorbirne il calore, poiché per sua
natura la poesia di Palmery lampeggia, sfrigola, fumiga, scoppietta, come
il tizzo in Inferno, XIII, o appunto come accade nelle pirotecnie
più mentali che ottiche del poema miltoniano. Malgrado la sua dedizione
alla pittura e il procedere in parallelo coi suoi modi cognitivi e costruttivi,
non vi è, crediamo, un poeta meno visivo di Palmery, e questo ancora
di più lo rende inattuale rispetto alla dominante cultura dell’immagine.
Il nervo ottico di Palmery manda impulsi dal cervello verso la pupilla,
e crea la visione a partire da una ghirlanda di parole, o meglio di frasi
strettamente intrecciate: ciò appare evidentemente in una poesia
che valga come citazione esemplare del suo libro oltre a essere una delle
sue più belle, Natura morta con ramo di quercia. Malgrado
il titolo pittorico, qui tutto è verbale e mentale, dalla parola
poetica il trapasso verso la moralità avviene in modo volante,
lasciandosi dietro un profilo appena disegnato dell’oggetto che doveva
fungere da connettivo materiale.
Il disegno, dunque, l’idea: dietro la maschera «secentesca»
e concettosa di Palmery si nasconde un solidissimo architetto di forme
e temi, un cacciatore sistematico di segni, un esprit à projets
che caparbiamente rifiuta il puntillismo di molta lirica odierna nel nome
di un’eloquenza che non cessa di interrogarsi sulle proprie posture
nel momento in cui avverte comunque la necessità morale (o se non
morale, almeno teatrale) di assumerne, a costo di apparire un dandy o
un predicatore o un asceta. La singolarissima tensione di questo poeta
rivela un possibile modo, in realtà molto contemporaneo, di declinare
la propria presenza/assenza nel mondo: quello di passeggiarvi assorti
nei sogni di una decifrazione integrale dell’esistenza, l’esercizio
mistico e metropolitano di Baudelaire.
«Pagine», XI, 30, settembre-dicembre 2000
GIARDINO DI DELIZIE E ALTRE
VANITÀ
di Luigi Fontanella
Il libro deve la sua nascita a una occasione, accidentale
ma decisiva: il catalogo di una mostra intitolata Les Vanitées
dans la peinture au XXVII siècle (Caen, luglio-ottobre 1990).
E ancora, lo stesso Palmery: «... l’idea e il desiderio di
fare un libro interamente ispirato alla vanitas si sono accesi
a quei colori, hanno preso forma da quelle immagini. Che sono i colori
e le immagini di Valdés Leal, Kalf, de Heem... E il progetto stesso
di un libro come catalogo – catalogo certo parziale, di parte, delle
cose del mondo – anche questo è nato di lì».
Poesia pertanto speculare, delle «macerie», questa di Palmery,
ma sono proprio esse a costituire – come viste dall’alto, in
un unico, conglomerante abbraccio visivo – il Giardino di Delizie
in cui (di cui) il poeta è chiamato a dare testimonianza con la
sua parola essenziale e sontuosa, e con la sua vita esperita e sentita
non altrimenti che come «lenta morte». Dunque poesia estrema
(e in estremo), a petto della quale il rischio è l’afasia,
o, per contro, appunto, il più sfrenato barocchismo d’accumulo,
nel quale l’Opera può risultare un Gioiello Stellare e al
contempo Vanità Totale. Palmery ha il dono e la scienza di possedere
la sottile capacità di trarre sensi da suoni (e viceversa), con
suggestioni e richiami di idee che si vestono di consonanze interiori
e assonanze esteriori, in un fluire labirintesco che è liberazione
e (auto)vessazione, incantamento e incatenamento: una macelleria virtuale
di cui il poeta è reo e innocente, vittima e boia. Il risultato
complessivo è una poesia contagiosa, di forte tenuta ritmica, tensiva,
avvolgente, spiralesca (senz’altro tra le più notevoli che
mi sia capitato di (e)leggere in quest’ultimo scorcio di millennio):
si veda p.e. il crescendo dell’ultima strofa del poemetto La stanza
e Testa di morto su un libro d’ore, per me uno dei vertici
in assoluto di questo libro.
«Gradiva», 19, Spring 2001
GIARDINO
DI DELIZIE E ALTRE VANITÀ
di Fabrizio Patriarca
Una certa pratica di giardini non è estranea al buon frequentatore
della poesia novecentesca: Franco Scataglini, Bruna Dell’Agnese,
Elio Fiore, Silvio Ramat. Tra giardini e orti, indietro fino a Montale,
chi percorre questi spazi chiusi non ignora quanto sappiano proteggere,
mascherare o stringere d’assedio, soffocare.
L’orto montaliano presta scampo alla fuga del porcospino, emblema
ritornante che altrove, in un luogo celebre, si abbevera «ad un
filo di pietà». Ma quell’orto era stato, al principio
della stagione degli Ossi, un «reliquiario», l’illusione
di una vita appena rinfrescata dal vento, e insistentemente minacciata,
presa tra le mura erte e inesorabili del «rovello». Pure,
lo stesso orto, lembo di terra o metafora che fosse, era detto da Montale
«crogiolo».
Il giardino, o l’orto, secondo le diverse tendenze (che forse sono
altrettanti ritagli della più lontana raffigurazione dantesca,
dal bosco dei suicidi alle dolcezze dell’Eden) suscitano il richiamo
della sicurezza come l’orrore della claustrofobia. Fuori dalla letteratura
si potrebbe individuare l’erede contemporaneo dell’ambiguo giardino
che popola l’immaginario dei poeti (spesso lo hanno chiamato hortus
conclusus) in quello che scorre davanti agli occhi, tipico e seriale,
vagabondando per la provincia americana: cinto dagli steccati di un bianco
innocente, armato di paletti acuminati che si ripetono minacciosamente.
Questo giardino di delizie di Palmery è infine un giardino in cui
è quasi impossibile entrare. Più che conchiuso, esso è
precluso. Ed anche penetrandovi, non è possibile respirare. In
breve: è il giardino perfetto.
Qualcuno però, ne ha da tempo chiarito il segreto: questo giardino
è un teatro, e il suo inventore va posto a buon diritto, assieme
a Sade, Fourier e Loyola, tra i «logoteti». Così Roland
Barthes definiva i fondatori di lingue.
La tesi di Barthes era semplice e niente affatto provocatoria: Sade, Fourier
e Loyola, ognuno con la fede prediletta (unico elemento che muta passando
dalla scrittura dell’uno a quella degli altri due), mostrarono «stessa
voluttà di classificazione, stessa furia di ritagliare (il corpo
cristico, il corpo vittimale, l’animo umano), stessa ossessione numerativa».
Come a dire tre «scenografi», il cui carattere non si rileva
dalla pressione sugli oggetti o dallo spessore dello stile, ma precisamente
dall’insistenza della scrittura.
Così, anche la scrittura di Palmery, in questo suo libro decisivo,
ossessivo, meticolosamente articolato, è instancabile, insistente:
la morte enumerata, catalogata, ricombinata è qui praticamente
«prescritta» attraverso l’esposizione, il teatro delle
vanità. Palmery è un logoteta perché la lingua di
questo libro è inflessibile: circolano e si combinano le definizioni
e le figurazioni mortifere con rigore inaudito, il teatro trionfa su tutto,
e col teatro i modi canonici della pratica dell’immagine, anch’essi
già riassunti da Barthes: l’imitazione, il quadro, la seduta.
Ne aggiungo due, altrettanto ineludibili e doppi: la parodia e la «quadreria»,
ovvero il quadro che ne contiene molti. Parodia di marca mitologica e
infernale: il nome della furia Aletto depotenziato e ridisciolto nella
figura del «seppellito sotto le coperte, a letto». Quadreria
esorbitante, sinceramente «irrespirabile», ne La stanza,
grande natura morta sulla vanità dove ogni oggetto è disincarnato
e reso quadro o cosa appena senziente, al modo dello stesso osservatore,
il cui profilo è sorpreso in chiusura raccolto nella cosa infernale
per eccellenza:
Al muro, in una nicchia, sopra il tavolo
più scuro, riparato tra i libri un argenteo
crocifisso di legno – ai suoi piedi un calice
opaco, profano – fotografie – Il Diavolo
di Plancy – e l’immancabile teschio:
il mio – che ispeziono con un dito allo specchio.
Palmery, partendo da un catalogo pittorico sulla vanità,
voleva realizzarne uno in versi, per sua ammissione «almeno parziale».
Ha fatto invece un giardino, che è pure un teatro, che è
pure un libro che a intervalli variabili suscita quel desiderio di discostamento,
quel timore d’asfissia che nella prosa ha un sicuro doppio nei racconti
notturni di Giorgio Manganelli.
Su questo libro, che insiste e disturba, si ritorna continuamente.
«Pseudolo», IV, 10, giugno 2002
|