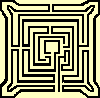| L’oro
ereditato
Il libro
Videoclip
Notizie sull'autore
Annelisa Alleva
Dello stesso autore
Lettera
in forma di sonetto
|
Recensioni
del libro L’oro ereditato
di Annelisa Alleva
UN DIARIO PRIVATO TRASFORMATO IN CANTO
di Franco Marcoaldi
È come una malia: soltanto nella distanza, nell’assenza,
il discorso amoroso riesce a prendere corpo. Soltanto quando l’amato
compare in sogno e si fa ombra, fantasma, mostra la sua natura vera. Di
più, e più dolorosamente: soltanto ora che quell’uomo
è morto, chi scrive riesce a comprendere la qualità del
proprio e dell’altrui sentimento: «Ma non potevo arrivare a
crederlo prima? / Rifarmi una pelle nuova, più sicura? / Avrei
potuto, così, amarti ancor più, / essere meno furente, fumigante,
addolorata».
Nelle poesie di Annelisa Alleva – un diario privato che si trasforma
magicamente in canto e perciò stesso nell’oro cui allude il
titolo – l’amore è tema centralissimo (in particolare
nella struggente sezione Per il sosia, dedicata ad un poeta che
era assieme «figlio, madre, maestro, amante»). L’amore
è un tema centralissimo perché di qui passa qualunque conoscenza
e rapporto con il tempo e il proprio corpo. I versi di Alleva giostrano
con sapienza tra l’ascesi del tono vocativo e una quotidianità
intrisa sempre di venature metafisiche; tra un passato abissale e l’osservazione
allarmata del presente: «Ora i miei fianchi / sono nido d’altri
pianti». Poeta del dettaglio e della narrazione, dell’introspezione
e della visione, Alleva trova nella Dickinson e nei pietroburghesi –
come lei stessa ci ricorda – le stelle polari della sua ricerca e
della sua scrittura.
«La Repubblica» – 14 gennaio 2002
SU L’ORO EREDITATO
di Paolo Maccari
«L’oro è... ereditato, potrei dire,
in parte geneticamente da un nonno di mia madre, uno scrittore e critico
musicale napoletano, in parte dall’incontro con un poeta, che si
è sviluppato nella distanza, ora resa definitiva dalla morte»:
cosí nella Notizia che chiude il suo nuovo volume di versi
Annelisa Alleva ne giustifica la scelta del titolo. L’oro ereditato
sarà dunque da intendersi come figura dell’attitudine alla
poesia, dell’impulso alla confessione scritta; una materia preziosa,
scintillante, che viene ricevuta da altre mani, trasmissione di una dote
che è anche – soprattutto – una nuova, emozionata e emozionante,
qualità dello sguardo.
Gran parte delle liriche che compongono la raccolta (divisa in quattro
sezioni: Dettagli al vocativo, L’oro ereditato, Per
il sosia, Nido di altri pianti) si rivolgono a un tu che non
assolve alcun ruolo d’«istituto» e nemmeno potremmo dire
che «i tanti sono uno»; l’amata seconda persona chiamata
di continuo in causa resta con persistenza ancorata alla sua identità,
anche quando la morte rende incolmabile e diversa la distanza tra i due.
Una volta che la baluginante vitalità dell’amato si converte
in silenzio definitivo, il dialogo procede in una sorta di diario sul
quale vengono appuntate le occasioni, i dettagli minimi di una fedeltà
che travalica il dato spirituale per farsi, come accennavamo, percezione
della realtà, modalità di reazione al variare dei fenomeni
e degli oggetti: «Davanti a un duomo, a un’abbazia che in vita
/ non avevi visto, ti ho pensato, e li ho fissati / coi tuoi occhi, cosí
avidi e capaci di bellezza. / Quest’omaggio ti feci. Tu sollevavi
piano lo sguardo, / e timoroso che l’abbaglio potesse darti il capogiro,
/ con una mano ti paravi la fronte, grato».
Se l’impresa della memoria e il riconoscimento di un legame che non
patisce allentamenti ridonano allo strazio della perdita una sempre nuova,
dolorosa attualità, un tale lascito consente quantomeno, una volta
che si apre la strada del canto, di vivere l’assente con un’intensità
– e una complessità di emozioni che sarebbe negata al semplice
ricordo. Con una pronuncia che predilige i modi discreti di un’aggraziata
colloquialità (peraltro impreziosita da una tessitura fonica elaborata,
sebbene dissimulata in rime al mezzo e in assonanze), l’Alleva costruisce
il suo canzoniere, ricco di episodi toccanti, assecondando una sensibilità
femminile avulsa da qualsiasi filtro intellettualistico: l’effusione
sentimentale procede liberamente, spudoratamente (e nella menzionata Notizia
si parla infatti di una poesia «senza tacchi né trucchi.
Pura. Spudorata.»): «[...] A chi è scorticato brucia
anche la seta, anche un bacio. / E così la tua morte oggi mi brucia.
/ Troppo presto, troppo all’improvviso, / senza dirmi niente [...].
/ è inutile che evochi le mie lacrime dal ciglio. / Il riverbero
della tua fiamma oggi mi brucia».
«L’immaginazione», febbraio 2002
L’ORO EREDITATO
di Idolina Landolfi
Suddiviso in quattro tempi (Dettagli al vocativo,
L’oro ereditato, Per il sosia, Nido di altri pianti),
questo sesto libro di Annelisa Alleva (il primo, Mesi, è
del 1996) comprende testi scritti nell’arco di vent’anni, e
rappresenta a mio avviso un punto d’approdo del fare poetico dell’autrice,
che in esso raduna ed esempla le tematiche più sue, dal senso inquieto
del tempo, paventato nemico, macinatore di vite, al canto inerme degli
affetti, o a quello ancor più inerme delle passioni, che baluginano
come oro dal fondo lacustre di queste liriche, e che di tanto in tanto,
sfidando ogni fisica legge, affiorano all’impietosa luce diurna.
Oro funesto, talvolta, e talaltra libero generoso elemento, cui si affida
il segreto di sé, la parte meno umana della propria natura.
Slavista, allieva di Ripellino, al quale ha dedicato articoli e saggi,
traduttrice di Puskin (Romanzi e racconti, Garzanti) e di Tolstoj
(Anna Karenina, Frassinelli), e, negli ultimi tempi, di poesia
russa contemporanea, la Alleva molto deve, nelle sue liriche, alla lezione
dei russi, dai classici dell’Ottocento all’Achmatova, alla Cvetaeva,
a un certo Majakovskij. Poesia, dunque, che si oggettiva, concretizzandosi
in immagini, in precisi dati spaziali, in gesti compiuti e non solo sognati;
che, in una parola, rifugge, o intenderebbe rifuggire, dall’astrazione.
Poesia «di servizio», anche, per la sua autrice; utile a comprendere,
ripercorrendo sentieri usati, traendo dal continuo fluire una goccia,
una frazione di tempo altrimenti imprendibile, e indecifrabile. E così
facendo la trasfigura, naturalmente, le conferisce un diverso statuto
di realtà, in un perpetuo gioco di rispecchiamenti, di trasfigurazioni
di sé e dell’altro. La ricerca del travestimento, della maschera
è così ciò che di primo acchito salta agli occhi;
come fosse, ogni frammento, una minuscola messinscena, un microteatro
dell’io ogni volta dalla prodigiosa novità. E oggi si è
amanti sottomesse e devote, donne dai nomi inventati (Anna Gatti), domani
eroine di romanzi, la Tat’jana dell’Onegin, o la Cécile
Volanges delle Liaisons dangereuses… «Oggi, ti prego,
giochiamo a fare / tu lo zar Ivan, io il principe Kurbskij…».
Gioco rischioso sovra tutti, in cui si rischia, cioè, di smarrirsi,
forse per sempre: e qui soccorre la scelta dello stile, quello scorrere
piano dei versi, il loro tono sussurrato e il personaggio, l’interlocutore,
al quale in tante liriche ci si rivolge col «tu»; in un inesausto
dialogo con l’assente, o comunque con chi è sentito di noi
maggiore, in certo senso una figura genitoriale, dalla quale la nostra
parte bambina pretenderebbe accettazione assoluta, e infinita cura. Ma
il sapiente è spesso insensibile, gretto, non ha occhi né
orecchie: e colei che scrive vorrebbe farsi piccina, tanto da entrargli
nel taschino. Oggetto tascabile, quasi invisibile, metamorfosi estrema
che è quasi morte: per amore, per sfinimento d’amore.
«Alias» – «Il Manifesto»,
20 aprile 2002
SANGUE E INCHIOSTRO
di Gianfranco Palmery
«Tu lavori nell’oro.», scriveva Sbarbaro
a Barile, «Io lavoro invece in una materia vile che ce ne vuole
a farla un po’ luccicare». Anche Annelisa Alleva non lavora
nell’oro: la sua è una materia che risponde alle forme opache
e passeggere della terra, a pelle, sangue, cibo, lenzuola... lavorate
strenuamente nella scrittura come fossero, o fino a farne, un aureo assoluto.
Questo però riesce perché dietro c’è altro oro:
l’oro che il poeta eredita nascendo, quello che negli anni di dedizione
acquista, e, soprattutto, quello che perde: tutte le petizioni edeniche
salgono dagli inferni della perdita. Se l’alchimia lulliana postulava
l’oro a partire dal piombo, la chimica del poeta parte dal sangue
e dall’inchiostro. Al sangue possiamo dare anche un altro nome: necessità.
Senza ferita non c’è necessità – e non c’è
sangue senza ferita... Lo spellato, lo scorticato, l’arrostito («Ero
un arrostito vivo accanto a te», recita in un attacco memorabile
una di queste poesie), o, mi pare sia in Rilke, la lumaca senza guscio
– pelle viva –: ecco delle realistiche raffigurazioni del poeta.
Scorticature, ustioni e ferite possono essere anche autoinflitte –
ma questo vuol dire semplicemente, prevenire il mondo... Insomma, la necessità
necessita tutto quel che al poeta accade: l’amore infelice come le
pene e le gioie di una clausura.
Anche l’inchiostro ha un altro nome, altri nomi: sapienza, consapevolezza,
riflessione sulla forma... Senza sapienza non c’è necessità
che non vada perduta: la necessità è la verità del
poeta, della poesia – ma si tratta alla fine di fare, per mezzo della
sapienza, della verità invenzione... L’oro della poesia, che
dopo ogni turbolenza chimica brilla quietamente, è verità
inventata.
Di sangue, e anche di lacrime, queste poesie sono robustamente irrigate
– nessun pericolo di siccità:
Tu entrasti a cascata, evento puro.
Le rupi fecero sangue, gengive
scavate dal bisturi (p.29)
oppure
[...] Lacrime sul dondolo, immobile,
sdraiata, formano una piscina nella cavità
oculare; quando mi volto cadono tutte assieme,
come da un secchio rovesciato. (p. 50)
Queste sono immagini / invenzioni che Laforgue avrebbe
definito yankee – cioè mirabolanti, estreme: crude e di una
razionalità fisiologica, ma anche meravigliosamente visionarie;
vogliamo vedere in esse il segno di un vivo, rinnovato barocco?
Io non ho dubbi: segni se ne trovano ovunque nella sua poesia, e prove
potrei portarne ad apertura di pagina: è un tratto radicale non
riducibile a quella vocazione all’iperbole che si usa riconoscere
all’io amoroso; tant’è che lo si può riscontrare
anche in uno scorcio di mondana intimità come questo:
Dentro il vestito di seta largo in vita
delle nozze, le amiche nascondono
un piccolo che scalcia al ritmo
della campana di un villaggio (p.38)
«Un piccolo che scalcia al ritmo / della campana
di un villaggio»... Mettere insieme un feto vivo e una campana squillante:
questo è ardito, ardente barocco; non un feto morto e una campana
di vetro: questo è stato crepuscolarismo... (E una conferma alla
genealogia barocca verrebbe, a seguire Dors, da quella parola, e realtà,
fuori d’uso in un poeta odierno e cittadino: villaggio; per Dors
infatti il barocco è campestre, il suo dio è Pan; non è
cristiano, è radicalmente pagano, ha a che fare con il pagus,
col villaggio).
E però notiamo come l’immagine outré, e insieme
familiare, sia contenuta con fermezza nella precisione descrittiva, («il
vestito di seta largo in vita / delle nozze...»), nel respiro, nel
passo metrico, così, diciamo, corrispondente, di due stretti e
elastici novenari. Immagini esorbitanti e ratio costruttiva dicono
il diritto di appartenenza di questa poesia alla famiglia del barocco
– e la rivelano anche armata di un’alta e bella retorica: ossia
la forma giusta e sapiente della sua verità. Cos’è
una poesia senza lo scintillio della retorica? La retorica è l’armatura,
la corazza dura e lucida, la forza di quella che passa per la «debolezza»
del poeta: la sensibilità; una poesia priva della retorica rivela
una presunzione muscolare incompatibile, oppure si affida a un’altra
retorica, quella del primo getto, per esempio, o dell’ingenuo, ecc.
Questa comunque non vuole essere l’applicazione di una categoria
come una schedatura; piuttosto il riconoscimento di un animus,
quello barocco, in una poesia che, come tutto ciò che è
ricco e vero, ha svolgimenti e vie di fuga, e non sopporta le restrizioni
di formule definitorie. Nei suoi aspetti strutturali del resto potremmo
scorgere anche il genio tutelare della poesia romana antica nel suo volto
duplice: una rotondità elegiaca che si affila in acuminatezza epigrammatica.
Ma diciamo che questa è la poesia di un poeta d’amore, un
poeta che canta i suoi oggetti d’amore con lucido abbandono e una
tenerezza compressa – talora così compressa che può
sboccare in invettiva, ironia, sarcasmo.
La pena splendente, o il doloroso splendore, di questi versi li fa deliberatamente
estranei alla ortodossia del decorativo e dell’indolore – sono
versi d’una oreficeria a tratti furiosamente impura, celliniana…
Un luogo comune vuole il poeta capace di rovesciare il canto dell’amore
– felice o più spesso infelice che sia – in amore del
canto: ed è vero, è la sacrosanta verità dei luoghi
comuni; altrimenti ci sarebbe solo amore, che non si sa bene cosa sia,
tanto aleatoria e multiforme è la sua natura, fluente, mutevole,
e sta lì, fuori, abbandonato ai giorni; mentre il canto c’è
e resta; e si può dire, noi abbiamo l’orecchio, se non il
cuore, per dire: qui c’è canto – meglio, una vocalità
drammatica che frequenta i toni alti e bassi, sa compitare staccati perentori,
o distendersi in larghe frasi melodiche, e con i suoi acuti come con i
suoi sottovoce può arrivare a toccare – a chi ancora presume
di averne uno – appunto, il cuore.
«Pagine», XIII, 35, maggio-agosto 2002
|